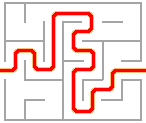
Il filo
di Arianna
marzo 2009
Giancarlo Livraghi
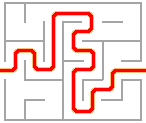
Il filo
di Arianna
Giancarlo Livraghi
Disponibile anche in
pdf
(migliore come testo stampabile)
Questo è il secondo
di due articoli nella rivista
l’attimo fuggente
sul tema della
comunicazione.
Il primo L’arte
di comunicare è
uscito nel dicembre 2008.
La comunicazione, oggi
Il paradosso dell’abbondanza
Abbiamo una molteplicità
e diffusione di strumenti
come non era mai esistita nella storia
dell’umanità.
Questa, senza dubbio, è
una risorsa.
Ma è anche un problema,
perché
non abbiamo ancora imparato a usarla.
Da circa trent’anni ci stiamo dicendo che siamo entrati “nell’era della comunicazione”. Devo confessare che c’ero un po’ cascato anch’io. Ma poi è successo che siamo andati a finire in un’era molto diversa da quella che ci aspettavamo.
Ci sono tanti testi sull’argomento. Ma tre libri, in particolare, mi avevano indotto a parecchi ragionamenti – e qualche speranza. Due pubblicati nel 1980, The Third Wave di Alvin Toffler e Le Défi Mondial di Jean-Jacques Servan-Schreiber. Uno nel 1982, Megatrends di John Naisbitt. Oltre agli studi del “Club di Roma” (Aurelio Peccei) che nel 1980 avevano aperto orizzonti di allarmante perplessità, ma anche di possibile progresso, poi un po’ troppo distrattamente dimenticati dalla cultura dominante.
Non ero, neppure allora, così ingenuo da pensare che una nuova ondata di ispirato illuminismo avrebbe magicamente risolto tutti i problemi delle culture e società umane. Ma leggevo con piacere, e con speranza, affermazioni come questa di Jean-Jacques Servan-Schreiber «Nell’era post-industriale la “finitezza” di sempre, che ci opprimeva e ci imponeva la sua legge, si infrange. A portata degli uomini si trova finalmente la risorsa infinita, l’unica: l’informazione, la conoscenza, l’intelligenza».
Era un sogno impossibile, una poetica illusione? No. Era, ed è, una risorsa vera. Ed è, oggi più che mai, “a portata” non di tutti, ma di quella parte dell’umanità che può disporre di adeguate risorse di informazione e di comunicazione (e che un po’ per volta sta crescendo, malgrado gli ostacoli, le repressioni e le gravi aree di privazione).
Parlare di “post industriale” era, ed è, pericolosamente impreciso. Nessuna civiltà moderna può sopravvivere senza industria – e sarebbe molto penoso per noi ritornare a quelle situazioni pre-industriali che sono molto lontane dall’essere così idilliache come le dipinge qualche arcadica nostalgia.
È ovvio che senza agricoltura non possiamo sopravvivere, perché sono ormai poche le parti del pianeta in cui si può vivere di ciò che cresce spontaneamente sugli alberi o nei prati – ma di questo un po’ troppo spesso tendiamo a dimenticarci, fino a quando si scatenano scarsità, carestie, inquinamenti e altri disastri che sarebbe stato facile prevenire se non fossimo caduti nell’illusione di un’infinita e inesauribile abbondanza.
Nessuno di questi problemi si può risolvere usando solo la comunicazione. Nel predominio delle apparenze, dove ciò che non vediamo ci sembra inesistente, possiamo illuderci che un problema non esista o non ci riguardi (o, al contrario, allarmarci esageratamente per qualcosa che è troppo enfatizzato). Ma il mondo reale esiste – ed è in quello che dobbiamo vivere.
Dove c’è sete o fame, malattia o privazione, occorre portare materialmente acqua e cibo, medici e medicine, eccetera. Ma la comunicazione è essenziale in ogni caso, per capire dove e quando ci sono le esigenze e come è opportuno cercare di provvedere.
C’è ancora un abisso fra le risorse di cui disponiamo (o di cui potremmo disporre se funzionassero meglio) e la nostra capacità di usarle efficacemente. Quali sono le cause del marasma in cui ci troviamo, del mancato (finora) avvento di un’autentica “era della comunicazione”? Lo vedremo alla fine. Prima osserviamo brevemente la situazione per alcuni dei modi di comunicare.
Il passaparola
Nel gran chiacchierare sulle nuove, o mutanti, risorse di oggi tendiamo a dimenticare lo strumento più antico: il passaparola. Non solo più che mai presente e attivo, ma anche moltiplicato dagli strumenti di comunicazione che scavalcano più facilmente le distanze.
Vedi Il passaparola – è il primo capitolo di Cenni di storia dei sistemi di informazione e comunicazione, un esteso documento che riguarda anche la stampa, i mezzi audiovisivi e i sistemi elettronici.
Non ho mai capito bene come facessero, duemila o duecento anni fa, a “passare parola” non solo nelle chiacchiere del villaggio, ma a distanze che ci sembrano impercorribili a piedi o a dorso di cavallo o di cammello. Correvano leggende e fantasie, favole e panzane, insieme a notizie vere e informazioni interessanti. E non è facile capire perché fossero così simili, nonostante le differenze di pensiero e di lingua, in culture che apparentemente non comunicavano fra loro.
Lasciamo ai progressi (spesso interessanti) dell’antropologia il compito di spiegare come e perché sia stato così fin dai tempi della preistoria. E vediamo che cosa succede nella situazione di oggi.
Nulla è cambiato, nella sostanza. Abbiamo oggi, come sempre, un inestricabile intrico di notizie utili e di sciocchi pettegolezzi, di pensiero interessante e di banali ripetizioni. Le “leggende metropolitane” sono una delle tante forme di stupidità, che continuano a moltiplicarsi non solo nelle infinite maniere del passaparola, ma anche in ogni genere di comunicazione, comprese quelle che sembrano “fonti autorevoli”, ma troppo spesso sono citate senza verificare la loro attendibilità.
Quella che è cambiata è la dimensione. Può sembrare un problema, ma se impariamo a capirla è una risorsa. Per il semplice fatto che possiamo comunicare facilmente, e in tempi brevi, con qualcuno che vive molto lontano dal nostro solito vicinato (o magari è a due passi da casa nostra, ma non avevamo avuto l’occasione di conoscerlo) abbiamo infinite e crescenti possibilità di vedere le cose in una prospettiva diversa.
L’arte di usare meglio il “passaparola” è una di quelle che non finiremo mai di imparare.
Le cose per scrivere
Può sembrare un dettaglio, ma anche gli strumenti più semplici sono cambiati e stanno cambiando. Fino al diciottesimo secolo si scriveva con la penna d’oca. Ancora nel 1966, nelle scuole elementari, erano d’obbligo pennino e calamaio. Ancora oggi, nelle università più tecnologiche del mondo, si scrive con il gesso sulla lavagna.
La matita, come la conosciamo oggi, è stata inventata nel 1762, la penna stilografica nel 1884, la penna a sfera nel 1938 e poi si sono moltiplicati i pennarelli (fino alle bombole spray degli autori di “graffiti”, che in rari casi possono essere davvero opere d’arte, ma in generale, nonostante le pretese di chi li vuole giustificare, sono solo abominevole sporcizia).
Nella seconda metà del diciannovesimo secolo le prime macchine dattilografiche. Dagli anni ottanta del ventesimo i personal computer.
Il primo prototipo di personal computer è del 1968, ma la diffusione è cominciata dieci anni più tardi. Pochi ricordano che i primi sistemi di scrittura elettronica derivavano dalla dattilografia, non dai calcolatori. Se lo sviluppo fosse continuato su quella strada forse avremmo tecnologie più efficienti e meno pasticciate. Ma l’esperienza dimostra (come le caso della telefonia mobile) che la tendenza alla complicazione è enorme, perciò siamo costretti ad attraversare la bufera perversa delle complicazioni inutili e invasive prima di approdare (chissà quando) in un più sereno porto di ragionevole efficienza.
Oggi ci raccontano che spariranno le tastiere, che si farà tutto a voce o toccando uno schermo, che un sensore sul cranio trasformerà il pensiero direttamente in testo, suono o immagine.
Speriamo di no. La perdita di controllo sugli strumenti può solo degradare la qualità del risultato. E un pensiero inespresso si può tradurre in chissà quali assurdità passando attraverso i criteri interpretativi immaginati da qualche tecnico nel suo più o meno bizzarro linguaggio.
Già oggi le macchine (ovvero le discutibili opinioni di chi le progetta) tentano di prendere il sopravvento, condizionando la nostra capacità di esprimerci. Il progresso, in forme tecniche che probabilmente nessuno ancora immagina, sta nell’aumentare il controllo umano sui meccanismi – non viceversa.
Stiamo disimparando a scrivere, o addirittura a parlare? Qualche problema c’è. Una mia esperienza personale, per esempio, è che, avendo cominciato da ragazzino a scrivere a macchina, la mia calligrafia è diventata illeggibile (come quegli sgorbi nelle ricette dei medici che solo i farmacisti sanno interpretare). Ammiro chi non è caduto in quella trappola e sa ancora scrivere in “bella calligrafia”.
Quanto all’uso della parola... stiamo attenti, perché gerghi e manierismi non sono soltanto banali – e spesso stucchevoli – ma rischiano di compromettere la nostra capacità di esprimerci e di capire. Varrebbe la pena di scrivere un articolo dedicato a questo argomento. Chissà, forse un giorno o l’altro lo farò.
C’è un accenno a questo problema in un breve testo che avevo pubblicato nove anni fa Il generale Biperio e il flop del wap (agosto 2000) e ci sono alcune osservazioni su un aspetto particolare, la confusione degli inglesismi, in Ambiguità di alcune parole inglesi.
I libri
Che fosse papiro o pergamena, inciso nella pietra o nel coccio, su tavolette di cera o su scorze d’albero, dipinto sulla tela o sulle pareti, arrotolato o a fogli stesi, piegato o rilegato... il libro è una risorsa essenziale delle culture umane da almeno cinquemila anni. E la sua identità è quella che ha assunto cinquecento anni fa, per opera di tecnici come Johann Gutenberg, ma ancora di più di umanisti come Aldo Manuzio.
Non voglio ripetere qui quello che ho scritto nel primo di questi due articoli, ma non è il caso di dimenticare che se Gutenberg avesse continuato a fare l’orafo, e Manuzio non si fosse mai occupato di editoria, nel giro di pochi anni ci sarebbe stata la stessa evoluzione, perché l’esigenza era forte, le risorse tecniche erano disponibili, e con lo sviluppo dell’umanesimo c’era un’esigenza che in qualche modo doveva essere soddisfatta. Lo stesso ragionamento si applica a tecnologie più antiche e più recenti, comprese quelle che nessuno ha ancora inventato.
Alcuni anni fa si temeva l’estinzione fisica dei libri, perché si era scoperto che (mentre i libri antichi, stampati su carta di stracci, durano nei secoli) la carta più recente era fragile e si pensava che si sarebbe irrimediabilmente sgretolata in polvere. Per fortuna l’allarme era eccessivo. Pochi libri, finora, hanno subito quella sorte – e comunque la qualità della carta, dopo una fase di decadenza, sembra ritornata a essere più affidabile.
Si teme, al contrario, che le tecnologie elettroniche, con i loro affannati e confusi cambiamenti, rendano progressivamente irreperibili testi e documenti conservati su supporti non più funzionanti o non più accessibili. L’allarme è probabilmente esagerato, ma il problema esiste – ed è davvero possibile che in qualche caso la carta stampata sia l’unica fonte recuperabile.
Insomma il libro c’è. E, nonostante i piagnistei, continua a crescere e a moltiplicarsi. (Mi piace sapere che quello che sto scrivendo sarà pubblicato in una rivista che ha la forma e la struttura di un libro).
Le confuse chiacchiere e i frettolosi esperimenti sul “libro elettronico” hanno prodotto disastri. Milioni di cd che intasano le pattumiere o sono appesi sui davanzali per allontanare i piccioni.
Certo, ci sono i libri in rete, dalle utili edizioni elettroniche dei classici ai testi che autori moderni rendono liberamente disponibili (fra i tanti ci sono anch’io). Dalle molteplici risorse di print on demand alle infinite possibilità di scambio – compresi gli utili servizi che permettono di trovare libri usati o comunque non più in distribuzione. Ma un libro è un libro – anche quando qualcuno se lo stampa in casa o in ufficio o sceglie la scomoda soluzione di leggerlo su un monitor.
Due cose sono in crisi: l’editoria e la distribuzione libraria.
Con l’elettronica è diventato facile, e poco costoso, stampare un libro, anche in poche copie. I diritti d’autore (salvo il caso di “famosi” che ottengono sostanziosi anticipi) si pagano sulle copie vendute. Si risparmia sui costi di redazione e impaginazione (e i risultati, ahimè, si vedono). Con mille copie si raggiunge il “pareggio”. E c’è anche il caso, più diffuso di quanto si immagini, di edizioni sovvenzionate dall’autore o da qualcun altro che ha interesse a far uscire un libro.
Così si pubblicano valanghe di titoli scelti senza cura e poi abbandonati al loro destino. Se, per caso, uno va, copre il costo degli altri. Quasi tutti hanno vita breve. In un anno o due – o anche in pochi mesi – spariscono dalle librerie e le copie restanti vanno al macero. Per far posto a qualche altrettanto effimera presunta novità.
Insomma gli editori (specialmente quelli grandi) sono in estinzione. Qualche nome rimane, all’interno di una grossa aggregazione, ma è solo un’etichetta nel catalogo di un librificio di massa – un mostro che divora i suoi figli con la stessa distratta velocità con cui li mette al mondo.
Così nascono e muoiono testi che non meritavano di essere stampati. Ma il vortice travolge ciecamente anche opere degne di un migliore destino. Per non parlare di quelle che forse esistono, ma difficilmente potremo leggere, perché sono state rifiutate da un editore troppo indaffarato a pubblicare qualche affrettato e squallido instant book su qualche argomento di moda – o l’ennesimo manuale su come coltivare i bulbi di tulipano.
Si piange, giustamente, sull’estinzione delle librerie. Sostituite da supermercati ciecamente enormi, in cui non solo non c’è presenza umana in grado di consigliare i lettori, ma è difficile trovare un libro anche quando si sa esattamente che cosa si sta cercando.
Un’eccezione, in questo marasma, è la vendita dei libri nelle edicole. C’è di tutto, comprese collezioni di scarsa qualità. Ma ci sono anche i “classici” e altri libri ben curati e pubblicati. Curiosamente questo canale di distribuzione non ha aumentato né diminuito la frequentazione delle librerie. E (per quanto possa essere disdegnato da chi preferisce scegliere negli scaffali di un libraio) ha messo nelle case milioni di libri, che presto o tardi qualcuno può aver voglia di leggere.
Anche la vendita online, che in Italia ha avuto uno sviluppo tardivo e debole rispetto alle grandi risorse internazionali, sta cominciando ad affermarsi. E quando è bene organizzata (ci sono ancora spazi rilevanti di miglioramento) è uno strumento valido e pratico per chi ha un’idea abbastanza chiara di che cosa sta cercando.
In questa evoluzione disordinata e confusa, stiamo andando verso l’estinzione dell’editoria e delle librerie? Forse no. L’epidemia è grave, ma non è detto che sia una malattia terminale.
Ci sono coraggiosi centri di resistenza. Ci sono editori, e ci sono librai, che continuano a fare bene il loro mestiere. E, nonostante le difficoltà, nuovi continuano a nascere. Diffido sempre un po’ delle statistiche, ma c’è qualcosa di vero in alcuni dati recentemente pubblicati. Pare che nel 2008 siano nati, in Italia, 197 nuovi editori e che le vendite di libri siano aumentate del venti per cento.
Insomma la partita è ancora aperta. Non si tratta di una Fenice che debba rinascere dalle sue ceneri, ma di un mondo di qualità e di attenzione che oggi sembra emarginato, ma non è stato, finora, distrutto da un irrimediabile incendio.
Ci vuole amore. Ostinata, vitale passione per i libri e per ciò che ci possono offrire. Più che gli autori contano i lettori. Più persone ci sono capaci di scegliere un buon libro, più quelli che ci sono potranno sopravvivere e più stimolo ci sarà, per chi è capace di farlo, a scrivere e pubblicare qualcosa di nuovo che meriti di essere letto.
In Italia, dicono tutti, si legge poco. Purtroppo è vero, ma non sembra che la situazione stia peggiorando. Se osserviamo i comportamenti dei più forti utilizzatori di nuove risorse, come l’internet, vediamo che sono le stesse persone che leggono più libri.
Le donne leggono più degli uomini. Non solo narrativa. Un sintomo e uno strumento della riscossa femminile.
Anche in questo senso, la partita è aperta. E anche questo è un problema che non si risolve in pochi anni. Le famiglie, la scuola, la cultura, tutti i sistemi di comunicazione dovrebbero impegnarsi meglio per diffondere la percezione di quanto un libro può essere utile. Per imparare, per sapere, per capire. O anche solo per divertirsi.
Giornali e riviste
Suonano da vent’anni le campane a morto sull’estinzione della carta stampata. Certo, giornali e riviste hanno sempre più concorrenza. Ma se qualcuno preferisce leggere un giornale in rete anziché comprarlo in edicola sta sempre leggendo un giornale.
La carta sarà sostituita da qualcos’altro? Chi lo sa. Lo si diceva dieci anni fa e una risposta chiara fu data da Jeff Bezos (fondatore e presidente di Amazon, la più grande libreria online) in un’intervista del 2000. “Se un giorno ci sarà un nuovo supporto che si può piegare, arrotolare, mettere in tasca, ritagliare, conservare o buttare nel cestino, insomma se sarà comodo come la carta, di qualunque materiale sia fatto in pratica sarà carta”.
Certo, oggi possiamo mettere migliaia di pagine di testo in un aggeggio portatile e leggere su uno schermo. Ma è molto meno comodo e pratico. Nulla, almeno per ora, ci fa pensare che la carta sia in estinzione. Se un giorno qualcos’altro sostituirà la carta, come ottocento anni fa la carta ha cominciato a sostituire il papiro e la pergamena, un libro sarà un libro e un giornale sarà un giornale.
Si temeva, una quindicina di anni fa, la morte del giornalismo. Altra profezia sballata – o infondata paura. Certo, è scomodo rinunciare a un privilegio. Chi scrive sul giornale ha il controllo, non solo di ciò che afferma, ma anche di come lo propone. Può parlare con i potenti, che lo ascoltano perché lo temono o perché cercano di essere favoriti. Il lettore sta nel gregge e si deve accontentare di quello che gli somministrano. (Oggi si tratta della televisione più spesso che della stampa, ma la gerarchia dei poteri è la stessa).
Con l’internet i ruoli sono cambiati. Ciò che un lettore attento poteva fare solo leggendo molti giornali e libri diversi, o passando giornate in biblioteca, oggi è molto più facile. Questo è un rischio per il cattivo giornalismo (che tuttavia continua ad avere fin troppo spazio) ma non per chi ha la vera capacità di dare testimonianza diretta o di essere un valido mediatore culturale. Anche in una situazione in cui tutti hanno parità di voce (cosa che in realtà accade raramente) chi conosce meglio un argomento e lo sa meglio spiegare ha comunque un meritato vantaggio.
I rischi non sono provocati da lettori meglio informati (o almeno capaci, se vogliono, di esserlo). I guai nascono da una degenerazione dell’editoria (in modo, in parte, diverso da quella dei libri). Da un’esagerata, e crescente, concentrazione in poche mani della proprietà di troppe testate. E dalle diffuse facilonerie del giornalismo di maniera. Che sia su carta stampata, per radio, in televisione o in rete, il problema è sostanzialmente lo stesso.
Continua a essere importante, insostituibile, il lavoro dei pochi e bravi che vanno a vedere di persona (talvolta rischiando la vita) o che si impegnano a fondo nell’analisi e nella verifica delle fonti. Un buon articolo, che spiega in modo semplice un problema complicato, può essere il frutto di anni di studio e di esperienza.
Il problema, anche in questo caso, sta nella qualità dei contenuti. Ci sono troppe concentrazioni, troppe situazioni di non sufficiente indipendenza. Troppa leggerezza nel pubblicare qualche “velina” o la distratta ripetizione di qualche luogo comune.
C’è soprattutto una mostruosa omogeneizzazione. La più futile delle notizie può diventare, a livello planetario, “il fatto del giorno”. La più bizzarra delle panzane può fare il giro del mondo prima che qualcuno si accorga che è un’idiozia. Mentre fatti davvero importanti sono ignorati – o relegati in poche righe a pagina quarantotto dove solo un occhio molto addestrato riesce a scoprirle.
La sbadata moltiplicazione delle testate non risolve il problema. Spesso affidate a qualche outsourcing a basso costo, o raffazzonate scopiazzando alla carlona, nascono e muoiono come le mosche senza lasciare alcuna traccia se non un po’ di confusione in più.
Se qualcuno immagina che le mie osservazioni, su questo come su altri argomenti, siano “nostalgia del passato”, vorrei spiegare che non è così. Un topo di biblioteca come me, che da ragazzo ha fatto anche il bibliografo di mestiere, non può non sapere che la fuffa c’è sempre stata. Ci sono, in tutte le epoche dell’editoria, ponderose opere elegantemente rilegate che non hanno alcuna utilità se non nell’arredamento degli scaffali.
C’è un’osservazione di Honoré Balzac citata, non a caso, da un brillante giornalista, Alberto Cavallari. «Se la stampa non ci fosse, bisognerebbe soprattutto non inventarla. Il giornalismo è un inferno, un abisso d’iniquità, di menzogne, di tradimenti, che non possiamo attraversare, e dal quale non possiamo uscire puliti».
Ci sono sempre stati contrasti, dubbi e polemiche È bene che la stampa, come ogni attività culturale, sia in grado di discutere anche su se stessa. I problemi ci sono, ma non si risolvono con i piagnistei.
La paura può essere peggio della realtà. I giornali non stanno morendo e non è moribondo il giornalismo. Né si tratta di reinventare un mestiere che ha secoli di storia. In parte opportunistica e squallida, come ci raccontava Orson Welles in un famoso film del 1941 (vedi Citizen Kane). Ma anche ricca di autentico valore culturale.
Si tratta di farlo bene, con impegno, con cura, con appassionata qualità e con la voglia di correre qualche rischio per uscire dalla prigione dei manierismi e dei luoghi comuni.
Non è facile. Ma ce n’è molto bisogno. Un pezzo importante della nostra civiltà dipende da giornalisti bravi, attenti, curiosi e coraggiosi – e da editori e direttori che sappiano trovarli e incoraggiarli.
Il cinema
Dicevano che il cinema avrebbe fatto morire il teatro. Era una scemenza – e infatti non è vero. Poi si è pensato che la televisione avrebbe ucciso il cinema. Altra panzana. Il cinema ha compiuto 114 anni e non dà alcun segno di vecchiaia.
(C’è una cosa che la televisione ha fatto sparire: il cinegiornale. Ma il cinema ha cento altre vite, compresa forse qualcuna che non è ancora stata inventata).
Verrà un giorno in cui saranno quasi dovunque grandi schermi al plasma, o qualcos’altro che li sostituirà, e il cinema si vedrà un po’ dappertutto, nelle piazze o nelle case, in sale diverse da quelle di oggi, che comunque sono già cambiate rispetto non molti anni fa? Chissà. Può darsi. O forse si evolverà in modi oggi imprevisti. Ma il cinema è il cinema, non cambia se sono diversi i proiettori, gli ambienti o gli arredamenti delle sale.
Da cinquant’anni vediamo i film in televisione, da trenta registrati in una videocassetta (ora un dvd) – e possiamo anche vederli sul monitor di un computer (cosa che personalmente trovo scomoda, ma ognuno fa come gli pare). “Andare al cinema” però è un’esperienza diversa. Nulla nelle prospettive oggi immaginabili ci dice che sia destinata a sparire.
I fratelli Lumière pensavano che le sale di proiezione si sarebbero chiuse quando la gente avrebbe smesso di stupirsi delle immagini in movimento. Era probabilmente vero che se il cinema fosse rimasto solo quello si sarebbe ridotto a qualche padiglione nelle fiere, fra una giostra e un tiro a segno. Ma si è presto capito che il cinema poteva fare altre cose. Raccontare storie. Documentare eventi o luoghi poco conosciuti. Nacquero presto anche gli “effetti speciali”, come nei film fantastici di Georges Méliès – e poi in capolavori come Metropolis di Fritz Lang. Straordinari se si pensa alla limitatezza tecnica delle risorse di allora. E con una fertile fantasia che oggi, un po’ troppo spesso, manca nell’uso banalizzato delle produzioni in elettronica.
Perché vale la pena di ricordare questa storia? Perché, oggi come allora, le tecnologie sono solo strumenti. La qualità dipende dalle capacità umane di autori, sceneggiatori, registi, attori, operatori, musicisti, eccetera – senza dimenticare l’indispensabile ruolo di un montaggio intelligente e di un’attenta segreteria di produzione. E questo vale, ovviamente, per ogni forma di comunicazione e di spettacolo.
Che cosa direbbe Eschilo, o Aristofane, o Shakespeare, o Molière, se vedesse le macchine di oggi? Non lo so. Ma immagino che, dopo un iniziale stupore, si metterebbe di lena a scoprire che cosa può fare con questi nuovi arnesi.
La radio
Dicevano che la televisione avrebbe fatto morire la radio. Un altro pezzo da mettere nel pittoresco museo delle previsioni sballate (che continuerà ad arricchirsi, man mano che se ne producono di nuove).
Che si ascolti su uno apparecchio statico, con una cuffia mentre si va a spasso, in automobile, con un computer o con un telefono cellulare, la radio è la radio, com’era quando ha sconvolto e trasformato il mondo della comunicazione più di ottant’anni fa.
Un fatto un po’ dimenticato è che la radio si era sviluppata, già in tempi che oggi sembrano remoti, non solo come broadcasting a senso unico, ma anche come dialogo personale, nelle reti tuttora esistenti dei “radioamatori” come nella navigazione marina e aerea e nel sistema CB (citizen band) particolarmente usato nelle comunità dei camionisti (con il loro pittoresco linguaggio di cui esistono divertenti vocabolari).
La cosiddetta comunicazione peer to peer (riassunta in P2P – una della miriade di sigle che servono più che altro a confonderci le idee) esisteva molto prima che nascessero le reti elettroniche.
C’è una tecnologia che, a causa della comunicazione diretta per radio, è praticamente estinta: l’alfabeto Morse. Un po’ è un peccato. Perché un metodo semplice di trasmissione a punti e linee si può usare in mille modi – non serve solo ai carcerati per mandarsi segnali da una cella a un’altra.
Non solo la radio è viva e vitale, ma in alcuni usi è insostituibile. E ha ancora interessanti possibilità di evoluzione.
La si può ascoltare in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo, anche dove non c’è corrente elettrica (esistono radio a manovella che non hanno bisogno neppure di una pila). Ha una velocità di informazione che nessun altro strumento può pienamente raggiungere (neppure la telefonia mobile, perché basta una pila scarica o una mancanza di “copertura” per renderla inservibile).
Non è un caso che bravi professionisti della televisione si siano formati nella radio. E anche chi non ha cominciato da lì considera interessante la sfida di quell’esperienza. La radio non è la “sorella povera”. È la mamma – e ha ancora molto da insegnare. Alla sua veneranda età non dà alcun segno di vecchiaia. Ha lo spirito e la vivacità di una ragazzina che sta ancora cercando di capire che cosa farà da grande.
È cominciato, ma non è compiuto, il processo di diversificazione e specializzazione delle emittenti radiofoniche. Non è facile capire quanto si possa evolvere nella musica, dove si fa sentire la concorrenza dell’internet e delle antologie personali. Ma un fatto è chiaro: non siamo ancora arrivati a una situazione in cui ci siano emittenti davvero selettive per genere e gusti musicali.
C’è un ovvio spazio di sviluppo nell’informazione, che può e dovrebbe essere meglio “segmentata” per genere di notizie e per orientamento di metodo e di opinione.
La radio (qualunque sia lo strumento con cui la si ascolta) è anche “unica nel suo genere” come presenza di compagnia. Molti la ascoltano non solo quando stanno guidando un’automobile, ma anche mentre lavorano. C’è anche chi (specialmente, ma non solo, mentre si occupa di faccende domestiche) lascia accesa la televisione e la ascolta senza guardarla. Cioè in quel momento, nonostante uno schermo inutilizzato, è una radio.
La televisione
Due cose sono di moda. Una è parlar male della televisione. L’altra è credere che tutto cambierà per motivi tecnici. Satellite, digitale, “alta definizione” – e non so che cos’altro qualcuno metterà in pista domani.
Sono sbagliate tutte e due. Se una trasmissione ci annoia, o ci dà fastidio, il problema non è “la televisione”. È come è pensato e realizzato quel programma. Ma purtroppo non è vero che “basta cambiare canale”. Benché l’offerta oggi sia abbondante, anche andando in giro con il telecomando troviamo spesso la stessa zuppa. E a questo non si rimedia con le tecnologie.
Il problema è l’abitudine. Il pubblico (specialmente quando è misurato con i “grandi numeri” su cui si concentra la contesa per l’audience) è abituato alla televisione così com’è e si aspetta che quella sia. Come è stato per secoli con l’opera dei pupi, o nella commedia dell’arte, oggi siamo doppiamente prigionieri – da due punti di vista. Chi fatica a fabbricare un’altra marionetta al posto di Orlando paladino, o inventare un’altra maschera al posto di Pulcinella. E il pubblico che quello si aspetta, malvolentieri accetta di dover imparare a capire nuovi scenari e nuovi contenuti.
Questo è un problema di tutta la comunicazione. C’è una generale “omogeneizzazione” di cui è difficile liberarsi. Da vent’anni ci stiamo dicendo che la televisione “generalista” dev’essere sostituita da qualcos’altro. Questo sarebbe un vantaggio non solo per gli spettatori e per le emittenti, ma anche per chi fa pubblicità e potrebbe raggiungere il pubblico più interessante con più selettività, meno spreco e meno affollamento. (Questo problema c’è anche con gli altri mezzi, ma è più evidente e ingombrante nel caso della televisione).
Dirlo è facile. Farlo, molto meno. Si tratta di reinventare un mestiere. Di rompere le abitudini e dare spazio alle “esigenze inespresse” del pubblico. Di ristrutturare gli strumenti di misura, troppo grossolani e troppo orientati genericamente ai “grandi numeri”.
Il problema è quello della gatta frettolosa. Nessuna di queste soluzioni può essere istantanea. Ci vuole tempo, pazienza, impegno per trovare nuove strade. Ci vogliono anni perché cambino gli orientamenti degli spettatori. Ci vuole sperimentazione e verifica.
La televisione è nata quando c’erano pochi canali (in Italia, all’inizio, uno solo). È ancora tutto da imparare il modo di farla quando possono essere centinaia. Insomma la televisione ha quasi sessant’anni, ma come la più anziana radio deve ripensarsi adolescente, reinventare la sua identità.
Se conoscessi la formula magica per fare nuova televisione, ci sarebbe una coda alla mia porta di ambasciatori carichi di ricchi doni. Ma in realtà non c’è alcuna miracolistica panacea. Ci sono molte cose da imparare, un passo per volta.
Come diceva Antonio Machado, «la strada si fa nell’andare». Non credo nei miracoli improvvisi, né al “nuovo assoluto”. È più probabile che in insieme di nuove idee e di maturata esperienza possa produrre i campi di sperimentazione che, imparando lungo il percorso, porteranno ai necessari cambiamenti.
Auguri a chi ci riuscirà. Forse diventerà ricco e famoso, forse no se qualcuno ruberà le sue idee. Ma si divertirà molto. E divertirà anche noi, umili spettatori, che nonostante la prigione delle abitudini, che non ci aiuta a scegliere (e nonostante il malcelato disprezzo con cui molti ci trattano) abbiamo, alla fine dei giochi, il potere di decidere che cosa ci interessa e che cosa no.
In questa, come in tutte cose, il primo passo è liberarci di una vecchia e sciocca banalità. “Il pubblico è un ragazzino scemo di undici anni”. A parte il fatto che ci sono ragazzini di undici anni tutt’altro che scemi, devo malvolentieri ammettere che ragionando in quel modo si possono ottenere risultati. Ma l’esperienza insegna che si possono ottenere risultati molto migliori facendo il contrario, cioè rispettando e stimolando l’intelligenza del pubblico. La fiducia è un valore che cresce nel tempo. Si può perdere facilmente se la si tradisce. Ma, quando c’è, è una risorsa preziosa.
Il problema è che la stupidità si diffonde e si moltiplica con la cieca invadenza di un virus contagioso, mentre l’intelligenza richiede disciplina, metodo, immaginazione, armonia di collaborazione e ostinato impegno.
La strada della stupidità è facile. È in discesa. Ma in quale abisso dovremo precipitare per capire che stiamo sprofondando?
Salire è più difficile e impegnativo. Ma non è affatto vero che per offrire contenuti di valore e stimoli interessanti si debba essere noiosi.
Chi saprà rompere (ovviamente non solo in televisione) il cap18.hm circolo vizioso della stupidità non solo passerà alla storia come benefattore dell’umanità, ma avrà anche esperienze stimolanti che sono negate a chi rimane sommerso nella palude dell’abitudine.
La cellulite
All’inizio non era una malattia. Ho un piacevole ricordo della confortante utilità dei primi impianti, quelli che pesavano chili, si tenevano nel baule dell’automobile con un’antenna sul tetto. A quell’epoca mi guardavano come un marziano perché ero riuscito a installare uno di quegli arnesi su una barca a vela e mi collegavo anche a decine di miglia dalla costa. Cosa che allora sembrava impossibile.
La telefonia mobile fu inventata nel 1947, ma i primi “cellulari” nacquero nel 1979 e furono messi in commercio nel 1983. Dieci anni più tardi cominciò una crescita più veloce, che ebbe una forte accelerazione fra il 1997 e il 1999, particolarmente in Italia. Il numero di telefoni cellulari ha superato quello delle linee “residenziali” nel 1998 e il totale delle linee “fisse” nel 2000. La curva di crescita ora si sta assestando, perché ci si è avvicinata a una soglia di “saturazione”.
Una sintesi dell’evoluzione della telefonia si trova nel decimo capitolo della già citata storia dei sistemi di comunicazione.
Ma siamo malati di cellulite. I telefoni diventano sempre più complicati e stracarichi di funzioni che poco o nulla hanno a che fare con la loro fondamentale utilità. L’invadenza è insopportabile, la schiavitù è opprimente, le difese ci portano a diventare irreperibili.
Per non parlare degli orripilanti sistemi di risposta automatica di tanti servizi pubblici e privati che rendono la più semplice richiesta un faticoso e snervante labirinto.
Sarebbe ora di invertire il percorso. Riportare il telefono a fare più semplicemente il suo lavoro. Installare o attivare altre funzioni solo per chi, e quando, le vuole. Impostare i servizi dal punto di vista delle persone che li chiedono e non di chi pensa solo a complicarli, per suoi motivi promozionali o per stupida incompetenza tecnica.
Questo è uno degli esempi più vistosi (ma non è certo l’unico) della crescente necessità di un risoluto cambiamento di gerarchia. Le macchine e i sistemi al servizio delle persone. Mai viceversa.
L’internet
Se vogliamo giocare agli anniversari, possiamo dire che nel 2009 l’internet compie quarant’anni. Fra le varie presumibili date di nascita, la più ragionevole è la costituzione nel 1969, negli Stati Uniti, del gruppo di lavoro ArpaNet – e la definizione del primo “protocollo” inter-rete, che poi, nel 1978, è diventato “internet”.
Oppure potremmo festeggiare i vent’anni del sistema world wide web, che non è la stessa cosa (anche se non è sbagliata, in pratica, l’attuale abitudine di considerare “internet” e “web” come sinonimi). Un concetto su cui anche altri stavano lavorando, ma prese il sopravvento la soluzione impostata da Tim Berners-Lee, al Cern di Ginevra, nel 1989.
Quando nel 1980 si parlava di “era della comunicazione”, quasi nessuno si era accorto che stavano entrando in gioco due risorse di cui non si percepiva il potenziale di diffusione. Il personal computer e l’internet. Tutte e due c’erano, ma neppure attenti studiosi ne tenevano conto. È interessante che si parlasse di “era della comunicazione” anche senza sapere che nuovi strumenti avrebbero aumentato la potenzialità della “risorsa infinita”.
Come la stampa cinquecento anni prima, anche la rete era “nell’aria”. Un’evoluzione che non molti avevano intuito, ma era inevitabile, fin da quando era nato il telegrafo nel 1844, il telefono nel 1877 e gli elaboratori elettronici nel 1939 (pensati inizialmente come macchine da calcolo, ma già nell’Ottocento si era capito che sistemi di quel genere potevano servire per altri usi).
Ci sono esempi più antichi. Non è esattamente vero che nel periodo ellenistico ci fossero i computer, ma recenti studi archeologici hanno trovato macchine meccaniche di notevole raffinatezza, che non servivano solo per “fare i conti”, ma anche per elaborazioni tecniche, studi astronomici e filosofici. Di quegli strumenti si sono perse le tracce per millecinquecento anni, fino a quando nel diciassettesimo secolo, e più industrialmente nel diciannovesimo, si è ricominciato a progettare macchine da calcolo capaci di gestire crescenti complessità. Vedi Il computer di Archimede e la cronologia in L’umanità dell’internet.
L’idea era chiara parecchi anni prima che se ne trovasse l’applicazione tecnica. Nel 1945 Vannevar Bush, in un articolo sull’Atlantic Monthly, aveva definito il concetto di un sistema capace di costituire una rete mondiale di condivisione della conoscenza.
Non è infondata l’opinione di chi sostiene che ipotesi dello stesso genere fossero state pensate da Lady Lovelace, cioè Ada Byron, figlia del poeta, nel 1843, sulla base di sistemi di calcolo ancora meccanici, ma già capaci di livelli di elaborazione molto elevati rispetto alle macchine precedenti.
Come nel caso della stampa, del telefono e di altre invenzioni, “i tempi erano maturi” per la nascita di un sistema come l’internet. Se non fosse stato realizzato dal Network Working Group negli Stati Uniti, si sarebbe arrivati a qualcosa di molto simile in base ai progetti che si stavano sviluppando, nello stesso periodo, in Gran Bretagna e in altri paesi europei.
Diversi sistemi di rete, e con diverse tecnologie, erano già sviluppati, anche su scala internazionale, all’inizio degli anni ottanta, prima che l’internet cominciasse a diventare utilizzabile fuori dal ristretto ambito universitario in cui era nata.
Quasi tutta l’opinione pubblica, e anche gran parte della cultura meglio informata, rimasero ignare di questi sviluppi fino a quando, a metà degli anni novanta, i collegamenti alla rete divennero largamente disponibili. Da allora si è detto e scritto di tutto e il contrario di tutto. Questo è uno degli argomenti più confusamente discussi e distorti, fra insensate paure ed esagerati miracolismi.
Una serie di analisi sullo sviluppo della rete in Italia, in Europa e nel mondo si trova nella sezione dati del sito gandalf.it
Potremmo dirci che se la rete, come fenomeno diffuso, ha circa quindici anni, è un’adolescente in cerca di identità. Ma questo serve solo a confonderci le idee. Non è vero che tutto stia cambiando vorticosamente e che ci dobbiamo reinventare ogni sei mesi. Come dico e scrivo fin dai tempi delle origini, la rete non è fatta di macchine, connessioni e protocolli. È fatta di persone.
È ora di smetterla con le mitologie e con le disquisizioni tecniche. E di imparare a capire la rate per quello che è: un utile strumento nella personale cassetta degli attrezzi che ognuno di noi organizza secondo le sue esigenze. Per comunicare, per informarci, magari anche per divertimento, sempre e solo come ci serve – senza mai permettere che qualcuno o qualcosa tenti di incanalarci dove non abbiamo alcuna intenzione di andare.
Troppe sirene cercano di confonderci. Giriamo al largo dalle loro trappole e andiamo dove ci porta la voglia e la curiosità. Il resto o è inutile o è pericoloso.
L’ambiguità dell’innovazione
Uno dei problemi, nel capire e gestire la molteplicità delle risorse, è l’ambiguo e distorto concetto di “innovazione”. Più se ne parla, meno si capisce che cosa sia. Il marasma è particolarmente evidente in alcuni settori, come le telecomunicazioni e l’elettronica, ma c’è anche in ogni genere di altre applicazioni.
La materia è complessa, ma il criterio di base si può riassumere in due semplici concetti.
La ricerca scientifica e la sperimentazione “pura” devono essere completamente libere. Troppo spesso non lo sono. Non si tratta solo del fatto fondamentale che la conoscenza è un valore in sé, ma anche delle infinite, e in molti casi verificate in pratica, soluzioni concrete che derivano da ricerche non mirate a quello scopo.
Le applicazioni tecniche, invece, sono inutili, spesso dannose, se non sono concepite e realizzate in base a specifiche esigenze e tagliate su misura al servizio delle persone che le usano. Molti problemi di cui stiamo soffrendo derivano da malpensati marchingegni concepiti dal narcisistico compiacimento di un tecnico o dal maniacale egoismo di chi vuol vendere qualcosa di falsamente nuovo rendendo inservibili metodi o strumenti ben funzionanti e solidamente collaudati.
Il “nuovo” fine a se stesso è una favola anche quando non è un imbroglio. Il vero progresso nasce da sviluppi più consapevoli ed equilibrati.
Il potere dell’oscurantismo
Non è il caso di ripetere qui ciò che ho scritto in un testo pubblicato nel numero 7 (luglio 2008) di l’attimo fuggente – Il potere dell’oscurantismo, capitolo 23 di Il potere della stupidità.
Mi limito a ricordare che non solo l’oscurantismo non è sconfitto, ma continua a imperversare, anche con repressiva e feroce violenza, in molte parti del mondo. E non ne sono immuni neppure quelle culture che si considerano più libere, consapevoli, civili, moderne e progredite.
Dobbiamo riscoprire i valori dell’illuminismo. Senza sperare che la Dea Ragione possa miracolosamente infonderci certezze. Il progresso della conoscenza è fatto soprattutto di dubbi. Come diceva Voltaire, «il dubbio è scomodo, ma la certezza è ridicola».
Lo smarrimento della conoscenza
Gli sviluppi della scienza sono sconcertanti. Più si va avanti e più si capisce che moltissimo resta ancora da scoprire. Ma intanto abbiamo già imparato molte cose che ci lasciano sbigottiti, perché mettono in crisi quelle che per millenni erano sembrate indiscutibili certezze.
Ma è inutile cercare rifugio nell’ignoranza. Il vaso di Pandora è irrimediabilmente aperto. Prometeo ha definitivamente tolto agli dei (o alle segrete confraternite di iniziati) il privilegio della conoscenza. E siamo solo agli inizi di uno sviluppo che (se nel frattempo non avremo scatenato qualche forza esageratamente distruttiva) ci porterà a scoperte che di nuovo cambieranno, non possiamo prevedere come, le prospettive del conoscere.
Copernico, che ai suoi tempi scandalizzava i benpensanti, oggi sarebbe sbigottito. Il suo universo andava poco oltre l’orbita di Saturno. Non poteva immaginare che il sistema solare fosse uno di miliardi nella galassia che è una fra miliardi di galassie.
E non è meno sconvolgente l’esplorazione dell’infinitamente piccolo, dove stiamo immaginando un numero crescente e confuso di “particelle”, di “onde”, di “forze” e di altri fattori di interrelazione perché non siamo ancora riusciti a capire quali siano, e come siano definibili, gli elementi di base del sistema.
È altrettanto radicale il cambiamento prodotto da Darwin e da altri che hanno definito la teoria dell’evoluzione. Uno sviluppo ancora in corso, che cambia profondamente il significato della vita, e dell’umanità, rispetto alle apparentemente presuntuose, ma in realtà umilianti, concezioni che ci collocano come creature privilegiate al centro dell’universo.
La percezione che oggi abbiamo è sconvolgente, ma non ha motivo di farci paura. John Updike lo spiega così. «L’astronomia è ciò che abbiamo ora invece della teologia. Meno terrore, ma nessun conforto».
Ha ragione. Sono molto più terrorizzanti le percezioni che ci hanno afflitto per millenni, di un’umanità preda delle bizzarrie di dei onnipotenti e capricciosi, di un perverso e immutabile destino, di forze demoniache, di streghe e stregoni, maghi e fattucchiere. La conoscenza è rischiosa, ma non è mefistofelica. È molto più dannosa l’ignoranza.
L’universo in cui viviamo non è quello dei quadri di Hieronymus Bosch. È la sconcertante bellezza di ciò che ci mostrano i telescopi o le microfotografie delle strutture viventi. Affascinante, ma ancora difficile da capire.
Il problema della scienza è che sta facendo enormi progressi in modo sempre più specialistico. Quella che ci manca è una visione di insieme, una filosofia nutrita di scambi “interdisciplinari”, insomma un nuovo Epicuro o un nuovo Lucrezio che ci sappia spiegare qual è, alla luce delle conoscenze di oggi, “la natura delle cose”. Non solo con rigore scientifico, ma anche con qualche slancio di umanità e di poesia.
Se questo sembra un discorso astratto, o troppo teorico, può essere il caso di pensarci un po’ meglio. Quella fusione di filosofia e poesia, di scienza e arte, di tecniche e mestieri, che ha prodotto lo splendore del Rinascimento, è ancora più necessaria oggi per avere una visione culturale, e applicazioni concrete, che nessuna specializzazione, per quanto raffinata, può ottenere separandosi dal resto della conoscenza.
Abbiamo bisogno di un nuovo umanesimo. Non è così difficile come può sembrare. Ma occorre che ognuno di noi, nelle grandi imprese come nelle cose piccole di ogni giorno, sappia guardare oltre i limiti delle sue prospettive abituali. Con inguaribile e inesauribile curiosità. Che si tratti di soddisfare con inaspettata semplicità l’urgente ed enorme esigenza delle energie rinnovabili o di assaggiare una polvere da pittura e inventare il risotto alla milanese.
L’abominevole impero della finanza
Qual è il mostro che ha divorato le nostre speranze, che ha preso il sopravvento mettendo in ombra e in crisi gli sperati lumi della nascente “era della comunicazione”? Sono tanti, di cui alcuni noti e prevedibili, altri che si nascondevano in oscure, ma estese, tenebre culturali di cui avevamo sottovalutato la presenza. Ma ce n’è uno in particolare che ha effetti devastanti. E non solo per la “crisi” di cui si sta parlando in questo periodo. È la finanza speculativa.
Non si tratta di aggiungere qualche dispersa goccia alla travolgente marea di inchiostro (e di chiacchiere) su questo argomento. Ma c’è un fatto chiaro di cui quasi nessuno sta parlando. Il problema era ben identificabile quasi trent’anni fa. Non è una coincidenza casuale che si tratti, anche da questo punto di vista, degli anni ottanta.
La finanza selvaggia, speculativa, avventuriera, c’è sempre stata. Ma qualcosa è cambiato all’inizio del penultimo decennio del secolo scorso. Quella che prima, anche se diffusa, era considerata un’anomalia divenne la regola. Trionfante e trionfale, lodata e ammirata, venerata come un nuovo culto mistico.
Non ho alcuna competenza specifica in finanza e amministrazione (ma forse, proprio per questo, ci vedo un po’ più chiaro di chi complica le cose fino a renderle incomprensibili). Era molto evidente, anche a un profano, che intorno alla metà degli anni ’80 era cominciato un grosso cambiamento non solo nel funzionamento del mercato azionario, ma in generale nel concetto di impresa.
Ci sono documenti precisi, di quell’epoca, che offrono chiare diagnosi sulla natura dell’infezione che è poi diventata epidemia. Per esempio un libro pubblicato nel 1990: Barbarians at the Gate di Bryan Burrough e John Helyar. Descrive con minuziosa precisione uno dei più clamorosi episodi di “conquista” di una grande impresa con la manipolazione di denaro immaginario. È stato ristampato molte volte, anche recentemente – e ne è stato ricavato un film. Ma era e rimane ignorato dall’opinione dominante, insieme ad altre testimonianze dello stesso genere.
Intanto i barbari hanno varcato tranquillamente il cancello, senza trovare resistenza – e si sono sontuosamente installati nelle stanze del potere. Fermarli allora non sarebbe stato difficile. Scacciarli ora è una battaglia molto più impegnativa. E, come stiamo tardivamente constatando, il costo è enormemente alto – non solo in termini di denaro, ma anche (e soprattutto) di sofferenza umana e sociale.
C’è anche una domanda preoccupante: se saranno davvero scacciati dal palazzo i furfanti e i giocolieri, gli indovini e i negromanti, dove si troverà qualcuno che sia in grado di governare l’economia, quando quasi tutti l’hanno disimparato?L’economia reale andava in eclissi. La speculazione sembrava poter produrre, all’infinito, ricchezza sempre crescente, senza alcun rapporto con beni concreti o servizi utili. Un immenso castello di carte, senza fondamenta né struttura, cresceva sempre più alto e sempre più rischioso. Era evidente che, in un modo o in un altro, sarebbe crollato.
Il problema è che la frana travolge non solo cartacce sventolanti e aliti irreali di denaro immaginario, ma fa crollare anche le mura del mondo reale. Sotto le macerie c’è l’intera economia di tutto il pianeta. E, ancora peggio, la sofferenza umana di chi perde il lavoro, la casa, la qualità della vita o le speranze per sé e per la sua famiglia.
Le bolle si gonfiarono e si sgonfiarono (una particolarmente evidente alla fine del secolo scorso). Era un sussulto che un buon sismologo avrebbe potuto individuare come prodromo di un devastate terremoto. Ma di quei segnali non si tenne alcun conto.
Alcuni casi vennero alla luce (qualcuno anche in Italia). Portarono a fallimenti e condanne penali. Ma si preferì fingere che fossero casi isolati, mentre erano solo piccole punte di un immenso e fragilissimo iceberg.
Non è facile capire quanto fosse il cinismo di après nous le déluge (certo molti sono scappati con la cassa – o hanno nascosto soldi veri in qualche “paradiso fiscale” dove sarà difficile andare a riprenderli). O quanto sia, semplicemente, maniacale stupidità. Ma non per questo perdonabile.
Ci vorranno alcuni anni per capire se avremo imparato la lezione o se, passata la buriana, ricadremo nella stessa trappola o in una diversa, ma altrettanto catastrofica. Se non saremo capaci di usare senza troppa miopia almeno il “senno di poi”, sarà un trionfo ancora più perverso del potere della stupidità umana.
Vedi Il (dis)senno di poi.
E domani?
Non ho alcuna intenzione di azzardare profezie. Potrei anche divertirmi a farlo – perché, come dice Scott Adams, «Prevedere il futuro è un ottimo modo per essere un autore di successo. Quando si scoprirà che le mie previsioni sono sbagliate sarò morto».
Scott Adams The Dilbert Future – Thriving on Business Stupidity in the 21st Century (1997) pagina 4. Non è un trattato sulla stupidità, né una “profezia” sul ventunesimo secolo, ma è un’acuta e ironica analisi della degenerazione strutturale e culturale delle imprese (che, negli anni seguenti, ha continuato a peggiorare).
Ma ci sono già troppi profeti, che sbagliano con tracotante supponenza (non è facile capire quanto lo facciano per arroganza e quanto per favorire interessi loro o altrui – occulti o fin troppo palesi). Mi convince di più la sintetica osservazione di Niels Bohr «Prevedere è difficile, specialmente il futuro».
Ciò non vuol dire che dobbiamo avventurarci nel buio senza neppure la lanterna di Diogene. Una cosa mi sembra chiara: siamo in una fase di turbolenza. Ovviamente ce n’è sempre stata, anche in quei periodi delle vicende umane che a distanza di secoli o millenni ci sembrano statici e quasi omogenei. Le lezioni della storia sono sempre utili. Ma è il tempestoso mare di oggi quello in cui dobbiamo trovare una bussola e tracciare una rotta.
È una pericolosa illusione credere che abbiamo imparato a governare i nuovi strumenti di cui disponiamo. Non solo sono fenomeni ancora in evoluzione, ma pochi decenni non bastano per aver imparato come si fa. Questo è un problema per chi va cercando false certezze o si illude di avere capacità profetiche. Ma da un altro punto di vista può essere un’avventura stimolante.
L’arte della comunicazione sta nell’esplorare le risorse, scegliere quelle che meglio corrispondono alle nostre esigenze, cercare e inventare percorsi, insomma “farsi una rete su misura” come dicevo in un mio libro di quasi dieci anni fa. Non solo nell’internet, ma in tutti i sistemi di comunicazione.
Plutarco diceva «se sai ascoltare, impari anche da chi parla male». Chissà che cosa direbbe oggi. Ma, in ogni caso, comunicare bene vuol dire soprattutto saper ascoltare. Non si tratta di “leggere fra le righe”, ma di capire quanto possiamo imparare non solo dalle notizie e osservazioni più stimolanti, ma a che dal contesto in cui si collocano le cose apparentemente più inutili e sciocche.
Non c’è umanità senza comunicazione. E nessuno, mai, può illudersi di aver imparato abbastanza. Il desiderio di imparare, cercare, esplorare, scoprire è la caratteristica più interessante della nostra specie. Se perdessimo quella qualità non avremmo più il diritto di chiamarci umani.