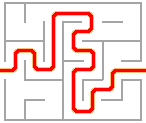
Il filo
di Arianna
dicembre 2008
Giancarlo Livraghi – gian@gandalf.it
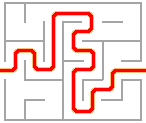
Il filo
di Arianna
Giancarlo Livraghi – gian@gandalf.it
Disponibile anche in
pdf
(migliore come testo stampabile)
Questo è il primo di due articoli
nella rivista l’attimo fuggente
sul tema della
comunicazione.
Il secondo Il
paradosso dell’abbondanza nel
marzo 2009.
L’arte
di comunicare
così nuova e così antica
Se vogliamo capire i complessi
sviluppi
che ha oggi la comunicazione, dobbiamo
basarci su ciò
che abbiamo imparato
da tutta la storia dell’evoluzione umana.
Communicare necesse est
È spesso ripetuta (non sempre a proposito) la frase navigare necesse est, vivere non necesse.
Secondo i repertori, fu citata la prima volta da Plutarco – detta (in greco) da Pompeo ai marinai che non volevano partire perché il mare era in tempesta. Divenne, mille anni dopo, il “motto” della Lega Anseatica (talvolta anche di altri, che non sempre lo usarono in modo sensato o civile).
L’intenzione è chiara, ma il concetto è discutibile. È vero che in ogni impresa umana occorre saper affrontare un rischio, ma un buon capitano deve saper governare in modo da portare a destinazione la nave, l’equipaggio e il carico – non solo di merci, ma anche di idee, identità e pensiero.
Quando si tratta di comunicazione, è abbastanza ovvio che vivere è necessario, ma per vivere occorre comunicare (e viceversa). I vocabolari ci dicono che in latino communicare vuol dire “mettere in comune, condividere, rendere partecipe”. Non è solo dire e ascoltare, è una necessità nell’esistenza delle persone e delle comunità umane.
Ciò che conta non è il latinorum, ma il fatto che la comunicazione è essenziale alla vita, in tutte le sue forme. Ed era così anche millenni prima di Socrate, di Platone e di tutti gli altri che si chiedevano (e ancora si chiedono) che cosa vuol dire “comunicare”.
Il nuovo e l’antico: che cosa non cambia?
Aldous Huxley diceva: «Che gli uomini non imparano molto dalle lezioni della storia è una delle più importanti lezioni della storia». In questo caso, non si tratta solo della storia, ma anche della preistoria.
Lo studio serio dell’antropologia è uno sviluppo recente. Ha preso forma da circa un secolo e si sta evolvendo in modo molto interessante grazie a nuovi e più precisi metodi di ricerca, compresa l’analisi del DNA. Più si approfondisce, più si scoprono nelle culture “primitive” strutture sociali, e capacità di comunicazione, molto più ricche di ciò che sembra nella visione convenzionale e barzellettistica di un cavernicolo armato solo di clava che trascina per i capelli una povera donna assoggettata.
Poiché ciò che in uno scavo archeologico distingue un uomo da un altro antropoide è soprattutto il ritrovamento di “manufatti”, è ovvio che prevalga la definizione homo faber . E saper fabbricare strumenti è davvero una caratteristica essenziale della nostra specie. Ma ne derivano considerazioni che non sono solo tecnologiche. C’è necessariamente un sistema di conoscenze che deve essere condiviso, insegnato, tramandato da una generazione all’altra. Cioè una cultura.
Come siamo “da sempre”
Questa non è una risorsa esclusiva dell’umanità. Sappiamo che esistono culture organizzate anche in altre specie. Ma ciò che ci interessa, in questo ragionamento, è il particolare sviluppo della comunicazione come risorsa indispensabile di ogni essere che si possa definire “umano”.
Ovviamente la parola, cioè la lingua. Una risorsa particolarmente evoluta e strutturata, per vocabolario e sintassi, come per modi di esprimersi, ritmi e tonalità. Ma si tratta anche di espressione artistica. Rappresentazioni simboliche e rituali, che sono pittura e scultura, ma al tempo stesso una forma di comunicazione scritta, anche se non “testuale”. Oggetti non solo praticamente utili, ma pensati e realizzati con gusto estetico.
Non è pensabile alcuna comunità umana in cui non ci siano anche la musica (ogni suono modulato è musicale) e l’architettura (che c’è anche in una capanna, in una struttura di palafitte o nell’arredo di una caverna). Anche la danza, lo spettacolo, la poesia, la letteratura (narrativa e non) e l’abbigliamento (che non è mai stato solo funzionale: il più “nudo” degli umani si addobba con vesti, accessori o colori che sono contemporaneamente espressioni estetiche e codici di identità o di appartenenza).
C’era la moda? Ovviamente si. E anche la cosmesi.
Ma non cambiavano a ogni stagione.Per tutte queste cose non possiamo indicare una “data di nascita”, una fase che ne segni l’inizio. Sono, semplicemente, antiche quanto l’umanità.
Possono esistere cultura, comunicazione, valori estetici e cerimoniali, linguaggi, suddivisione di ruoli, usanze e tradizioni, anche in specie diverse dalla nostra. Ma non può esistere umanità senza uno sviluppo, ricco e complesso, di tutte queste risorse. E in nessun’altra specie c’è quella particolare combinazione di tecnica ed estetica, di funzionale e simbolico, che si riassume nella tradizionale, quanto chiara, definizione “arti e mestieri”.
Capire le radici
Abbiamo l’impressione di vivere in un’epoca di continuo cambiamento. In parte, è vero. Ma non tutto è nuovo – e non sempre ciò che è (o sembra) “innovazione” è un miglioramento. Ci sono cose che abbiamo dimenticato e che dobbiamo riscoprire, come ci sono errori e nefandezze di cui ci eravamo liberati (o così sembrava) e in cui stiamo ricadendo.
Se dovessimo cercare di capire la turbolenta complessità in cui ci troviamo basandoci solo sulle esperienze di oggi, sarebbe difficile, confuso, sconcertante e superficiale. Per fortuna non è così. Gli strumenti cambiano, l’umanità resta. La natura fondamentale di un essere umano non è cambiata in decine di millenni – e l’essenza della vita è la stessa fin dalle più remote origini dell’evoluzione.
La vita è comunicazione
L’argomento è complesso, ma (se ci azzardiamo a semplificarlo) possiamo dire che la vita è comunicazione. Un essere vivente non è un “oggetto materiale”, è un’idea. È un disegno strutturale che governa l’aggregazione delle molecole, che si evolve con la sua capacità di riprodursi, che continuamente modifica l’ambiente e ne è modificato.
La vita, se non comunica, non esiste. Più che badare alla vecchia (e un po’ insulsa) domanda sull’uovo o la gallina, potremmo chiederci se è nato prima un protozoo o il “concetto” (vogliamo chiamarlo algoritmo?) che è la sua identità biologica, la sua “ragione di essere”.
L’evoluzione ha portato molte specie di esseri viventi a forme complesse di relazione e comunicazione, necessarie alla loro sopravvivenza. Continua a crescere, con conseguenze spesso illuminanti, lo studio della sociologia che è presente in tanta parte della biologia (e viceversa). Ma ciò che ci interessa, qui, è il particolare ruolo della comunicazione nelle società e civiltà umane.
Communicare humanum
La comunicazione è particolarmente importante per la nostra specie. Non può esistere un essere umano senza una complessa ed evoluta capacità di comunicare. Che, di base, è un “istinto”, una caratteristica genetica. Ma in gran parte è apprendimento.
Un bambino comincia a percepire ancora prima di nascere. Ma poi deve affrontare un lungo e impegnativo percorso per distinguere la sua identità e quella degli altri, capire come si comunica. È uno sviluppo che dura per tutta la vita – non si finisce mai di imparare.
Se è così per ognuno di noi come persona, lo è anche per ogni comunità, organizzazione, ambiente culturale. Una “navigazione” basata su una chiara idea di dove si sta andando e perché, insieme all’esplorazione di percorsi verso l’ignoto, per scoprire ciò che ancora non si sa o non si è sufficientemente capito.
È sempre stato così fin dalle origini – e non c’è in vista alcun orizzonte che non debba essere superato per poter vedere ciò che si nasconde al di là del suo apparente limite. Navigare necesse est, nelle acque non sempre tranquille della conoscenza. Anche se, così facendo, non si rischia la vita, dobbiamo essere pronti a sacrificare qualche pregiudizio o preconcetto, a scoprire che quando la Fenice delle idee rinasce dalla sue ceneri non è mai del tutto uguale a com’era prima. Ma il “nuovo” non ha senso se non sappiamo capire quanto contiene di “antico”.
Che cosa è cambiato, nei secoli e nei millenni? Molto, ma non le basi fondamentali del nostro esistere e pensare. Senza mai dimenticare i valori di continuità, credo che sia importante capire come alcuni cambiamenti abbiano avuto un effetto particolarmente importante. Con una semplificazione un po’ riassuntiva, ne possiamo elencare sei.
Una descrizione più estesa di questi sviluppi si trova in
Cenni di storia dei sistemi di informazione e di comunicazione.
La scrittura – cinquemila anni fa
Non c’è mai stata un’epoca in cui la comunicazione fosse solo “lingua parlata”. Nei millenni dell’evoluzione umana c’era stata una convergenza fra rappresentazione visiva e linguaggio, che aveva portato a sistemi complessi di grafia, in cui è difficile distinguere fra ideogrammi concettuali e segni che rappresentano parole, suoni, numeri o strutture espressive. Non abbiamo finito di scoprire le origini della “lingua scritta“ ed è probabile che, più attentamente si studiano, più si tende a risalire a epoche più antiche. Ma sembra chiaro che la scrittura, come la intendiamo oggi, è nata circa cinquemila anni fa.
Possiamo chiamarla “la nascita della storia”. Possiamo chiederci se l’abbiano sviluppata prima i Sumeri, gli Egizi o i Fenici (cui si attribuisce la definizione di un alfabeto fonetico). Ma comunque segna un cambiamento fondamentale. Che coincide con lo sviluppo dell’agricoltura, il passaggio da nomadi a stanziali e la definizione di sistemi di governo, norme e leggi, su scala più ampia di quelle delle tribù. Le prime scritture furono di contratti, regole e decreti – venne più tardi l’uso per la letteratura, la poesia, la storia e il pensiero.
Insomma la scrittura è uno strumento che è nato dalle necessità di una fondamentale fase evolutiva della nostra specie – e che da allora ne segna profondamente lo sviluppo. Non sempre ci rende più sapiens, ma è un fatto che senza la parola scritta non potremmo essere ciò che siamo e che stiamo diventando.
La stampa – cinquecento anni fa
La stampa non è nata con Johannes Gutenberg. Nella più grande biblioteca del mondo, la Library of Congress a Washington, che contiene 138 milioni di libri e altri documenti, c’è un testo stampato (brani di un sutra buddista) del 770 d.C. (il più antico scritto in quella biblioteca è una tavoletta cuneiforme del 2040 a.C.).
Ma è vero che c’è stato un profondo cambiamento nel quindicesimo secolo. Dovuto all’incontro (o convergenza) fra risorse tecniche ed esigenze culturali. Ma forse nessuno si sarebbe impegnato a scoprire come diverse tecniche si potessero mettere insieme nella stampa se non fosse stato spinto dalla crescente richiesta di un metodo per produrre più libri e in un maggior numero di copie.
Lo sviluppo dell’umanesimo aveva bisogno di risorse per una maggiore diffusione della parola scritta. Le fiorenti università volevano riproduzioni esatte, in molte copie, di testi uguali (c’erano botteghe di copisti in cui uno dettava e gli altri scrivevano).
Nella seconda metà del quindicesimo secolo si sviluppò una nuova cultura e una nuova realtà d’impresa: l’editoria. Non si trattava solo di stampare, ma di “fare libri”. Si inventarono nuovi caratteri, stili di impaginazione, la punteggiatura, la numerazione delle pagine, la redazione, le edizioni critiche dei testi classici, eccetera.
Gli italiani ebbero un ruolo importante in quello sviluppo. Non solo per le risorse tecniche, come la qualità delle cartiere di Fabriano, ma soprattutto per opera degli umanisti – in particolare Aldo Manuzio.
La stampa si diffuse rapidamente in tutta Europa. Si calcola che nella seconda metà del Quattrocento si siano stampati più di 30 mila libri in 20 milioni di copie – più di quante ne potevano aver prodotto gli amanuensi in tutta la storia precedente.
Nel Cinquecento le copie divennero 200 milioni, le edizioni fra 150 e 200 mila. Lo sviluppo continuò a tal punto che nel 1680 Gottfried Leibniz si preoccupava di «un’orribile massa di libri che cresce incessantemente».
Le tecniche di stampa si sono evolute nel tempo, ma mantengono sostanzialmente la loro impostazione originaria. Le rotative cominciarono a svilupparsi fra il 1861 e il 1867. Vari metodi di composizione meccanica furono sperimentati fra il 1820 e il 1896, ma l’evoluzione risolutiva venne con l’invenzione della linotype nel 1886 e della monotype nel 1890 (solo dopo la metà del ventesimo secolo sostituite dalla fotocomposizione e poi dall’elettronica).
Con le tecnologie molte cose sono cambiate, ma non sempre in meglio. Il concetto di editoria sarebbe migliore oggi se si ragionasse come ai tempi di Aldo Manuzio.
“In principio era il libro”. Ma la stampa periodica era già sviluppata nel Seicento – e nel Settecento esistevano i quotidiani (in Italia dalla metà dell’Ottocento). Ciò che mancava era una diffusa “alfabetizzazione”. La lettura era un privilegio di pochi.
Solo nella seconda metà del ventesimo secolo si è arrivati a una situazione in cui quasi tutti in Italia sanno leggere e scrivere – anche se, ancora oggi, si stima che due terzi della popolazione italiana abbiano “competenze alfabetiche molto modeste”.
Del ruolo della stampa, e in generale della parola scritta, nella situazione di oggi parleremo nella seconda parte di questa analisi, che uscirà nel prossimo numero.
La “rivoluzione copernicana” – quando?
Non è vero che un concetto eliocentrico sia stato proposto per la prima volta da Copernico o da Galileo. L’avevano pensato anche alcuni filosofi greci e altre culture antiche. Ma la visione tolemaica, con la terra al centro dell’universo (se non addirittura piatta, come molti credevano) aveva avuto il sopravvento in tutto il Medioevo.
È vero, invece, che il tema divenne di attualità, e suscitò molto scandalo, fra il sedicesimo e il diciassettesimo secolo. Non si tratta solo di astronomia. Si sconvolge un enorme errore di prospettiva. Crolla la millenaria presunzione umana di essere in una posizione privilegiata.
Non è certo l’unico, fra gli sviluppi del processo scientifico, a cambiare la prospettiva in cui si colloca la nostra specie (è stata, e in parte è ancora, altrettanto sconvolgente la scoperta dell’evoluzione). Ma è un fatto che, in molti modi, le percezioni più diffuse sono ancora sostanzialmente “tolemaiche” – non solo in senso astronomico.
Un articolo su Il potere dell’oscurantismo
(capitolo 23 di Il potere della stupidità)
è uscito nel numero 7 – luglio 2008 di l’attimo fuggente.Questo è un processo ancora “in divenire”. Solo nel ventesimo secolo abbiamo cominciato a capire che l’intero sistema solare è una minuscola particella di un sistema smisuratamente più esteso, con miliardi di galassie. Per quanto possa sembrare una nozione acquisita, poche generazioni non bastano per capirla.
Non si tratta di “sentirci piccoli”. L’impegno è molto più profondo: è il “sapere di non sapere”. Chi pensa di aver capito il senso dell’universo o è stupidamente presuntuoso – o dev’essere pronto ad avere grossi dubbi la prossima volta che l’esplorazione del cosmo, strettamente imparentata con la fisica dell’infinitamente piccolo, metterà di nuovo in discussione le teorie che finora siamo stati capaci di elaborare.
Possiamo trovare, anche a questo proposito, pensieri interessanti nelle filosofie di tremila anni fa o nelle più antiche tradizioni di tutte le culture. Ma, per quanto paurosamente diffusa sia ancora l’ignoranza, insieme al pregiudizio e al dogmatismo, non siamo più in una situazione in cui “il sapere” possa essere il privilegio di pochi.
La perdita di certezze apparenti, di percezioni abituali, di orizzonti ristretti può fare paura. Ma la curiosità della conoscenza può essere molto più forte.
La “rivoluzione del conoscere” è cominciata da poco ed è ancora agli inizi. Il cambiamento di prospettiva è la più grande evoluzione culturale nella storia dell’umanità. Se le generazioni future saranno o no più sapiens di tutte quelle precedenti dipenderà soprattutto dal capire le conseguenze di quello stiamo tentando di imparare.
La libertà di stampa – da duecento anni
Può sembrare che questo non sia un cambiamento profondo nella comunicazione paragonabile agli altri che sto elencando. Forse non lo è in questo specifico modo. Saranno gli storici di secoli futuri a capire se l’evoluzione è segnata in modo particolare da ciò che è accaduto alla fine del diciottesimo secolo o se andrà vista in una prospettiva diversa. Ma in questo momento della nostra storia stiamo ancora imparando come convivere con un concetto che ci sembra ovvio, ma non ha ancora avuto il tempo di sviluppare radici abbastanza robuste.
Il concetto di libertà aveva scarso spazio per potersi affermare nelle culture umane delle origini. È vero che la struttura intrinseca (genetica e culturale) della nostra specie è una inscindibile mescolanza di individuale e sociale, ma non è mai stato facile conciliare i diritti personali con le esigenze collettive.
Non siamo api, né formiche. Ma non possiamo neppure essere del tutto homo homini lupus. Una complessa interazione di individuale e collettivo (con tutte le complicazioni che ne derivano) è essenziale alla sopravvivenza e all’evoluzione dell’umanità. Le cronache e i dibattiti di oggi dimostrano quanto siamo ancora confusi nel cercare un efficace equilibrio fra le due “necessità”.
Quando è nato il concetto di libertà di stampa, cioè il diritto di esprimere liberamente e pubblicamente, con qualsiasi mezzo o strumento, le proprie opinioni, di comunicare informazioni “a tutti” anziché a pochi privilegiati? Da “solo” 232 anni si è cominciato a definire formalmente questo diritto – e ancora oggi esiste solo in una parte del mondo.
La ricerca della libertà c’era anche in culture antiche, ma il fatto è che la conoscenza era concentrata nelle mani di pochi. Il mito di Prometeo e il vaso di Pandora sono solo due fra tanti esempi di quanto il “sapere” fosse considerato “empio” e pericoloso.
Benché ci siano state anche migliaia di anni fa forme di democrazia, la struttura del potere è sempre stata concentrata in due modi: quello della forza (prevalentemente maschile) e quello della conoscenza (spesso femminile – non solo divinità e sacerdotesse, ma anche le sibille, le pizie, la Sfinge e tante altre).
Il terzo, ovviamente, è il denaro – ma nel breve spazio di questo articolo possiamo solo accennare al fatto che è molto pericolosa la mescolanza del potere economico con il potere politico e con il controllo della comunicazione. Come era chiaramente noto anche in tempi antichi, ma è vistosamente palese nella situazione di oggi.
La libertà di stampa fu definita come diritto, per la prima volta nella storia, dal bill of rights della Virginia nel 1776 e poi dalla costituzione degli Stati Uniti nel 1789. In Inghilterra la censura fu abolita nel 1795. La legge si diffuse poi, gradualmente, in altri paesi. In Italia fu stabilita dallo Statuto Albertino del 1848 e poi dalla Costituzione del Regno nel 1861.
(Nella storia del Risorgimento non è sempre rilevato il fatto che, oltre ad altre risorse come forze militari piccole, ma bene addestrate – vedi il caso della guerra di Crimea – e a un gioco efficace di alleanze, fra le abilità di Cavour ci fu quella di offrire a Torino e a Genova libertà di stampa a giornali e riviste sottoposte a censura in altre parti d’Italia).
E oggi? In una larga parte del mondo non c’è libertà di stampa, di informazione e di opinione. Dove, come in Italia, è sancita dalla legge e radicata nella cultura, il quadro è tutt’altro che chiaro. Anche questo è un tema su cui ritorneremo nel prossimo articolo.
La “contemporaneità” – da “non molto”
Sono sempre esistite forme di comunicazione “a distanza e in tempo reale”. Tamburi, campane, trombe, eccetera, segnali di fumo (o di fuoco nella notte – compresi i fari per la navigazione, che esistevano più di duemila anni fa). Ma non vanno così lontano come le risorse che oggi ci sono abituali.
Ai tempi di Giulio Cesare c’era un sistema di telegrafo (una rete notturna di segnali di fuoco) che permetteva di collegare Roma con le legioni nelle Gallie. Più veloce di quanto sia, ancora oggi, una lettera spedita per posta, ma non paragonabile ai sistemi che si sono sviluppati nel diciannovesimo secolo.
Le “date di nascita” sono più di una. Il telegrafo nel 1844, il telefono nel 1877. Il “telegrafo senza fili“ dal 1895, ma con un cambiamento fondamentale con l’esperimento di Marconi nel 1901, la prima trasmissione transoceanica, che apriva la via alle comunicazioni oltre l’orizzonte, da un’estremità all’altra del pianeta.
C’entrano, ovviamente, anche la fotografia (1837), il cinema (1895) e il grammofono (1887) con vari successivi sviluppi di audio e video registrazione. E anche la ferrovia (1804), l’automobile (1883) e l’aeroplano (1903) perché la “mobilità fisica” è un elemento fondamentale nelle nostre capacità di conoscere e comunicare.
Contrariamente a ciò che si usa dire, Marconi non aveva inventato la radio e non pensava di usare in quel modo le onde hertziane.
Marconi era preoccupato della riservatezza – un problema oggi imperversante.
Perché i telegrammi personali, trasmessi “senza fili”,
potevano essere più facilmente intercettati.Ma era inevitabile che dal “telegrafo senza fili”, e da altre risorse che si erano sviluppate, derivasse una forma diversa di comunicazione (quasi) immediata, non solo “da uno a uno”, ma diffusa a tutti coloro che potevano avere un apparecchio ricevente. Si sviluppò così, nel ventesimo secolo, il broadcasting – cioè la radio e la televisione.
Dopo gli esperimenti fra il 1906 e il 1916, la prima emittente radiofonica nacque nel 1920 negli Stati Uniti. Negli anni seguenti la radio si diffuse in Europa (in Italia nel 1924).
La televisione esisteva dal 1936 (a livello sperimentale dal 1925) ma fu sviluppata in modo esteso dopo la seconda guerra mondiale (in Italia nel 1954). Di sviluppi più recenti parleremo nel prossimo articolo.
È online una “cronologia” delle risorse
di informazione e comunicazione, dal 1700 a oggi.È difficile per noi, oggi, immaginare un mondo in cui non esista la contemporaneità, cioè la possibilità di comunicazione a distanze sempre più grandi e in tempi sempre più brevi, fino ad arrivare alla situazione attuale, che ci permette (quando e dove i sistemi funzionano) di comunicare “quasi” subito, “quasi” con tutti e “quasi” dovunque. (Ma, ancora oggi, nei “quasi’ si nascondono vaste aree di privazione – e non poche distonie di funzionamento).
Il fatto è che, per quanto “normale” ci possa sembrare, è uno sviluppo molto recente rispetto alla storia dell’umanità. E non abbiamo ancora capito bene come orientarci in questa situazione.
La “globalità” – “lavori in corso”
Il mare di chiacchiere sulla “globalità” o “globalizzazione” è assordante. Quanto inconcludente, pretestuoso e confuso. Il fatto è semplice: i sistemi di comunicazione non hanno reso piccolo il mondo, ma enormemente aumentato la nostra capacità di conoscerlo.
Nessuno può pensare che sia possibile, o desiderabile, tornare indietro, richiuderci nella culla del villaggio o della microcultura, sperando di poter restare isolati quando ciò non è mai stato possibile, perché da inaspettate provenienze potevano sempre arrivare sorprese, spesso amare e crudeli quanto impreviste.
Non abbiamo altra scelta che imparare a vivere in un mondo più aperto, che ci può offrire esperienze affascinanti, ma contiene anche pericoli di cui è giusto avere paura.
Una cosa che, pur avendo cercato di studiarla, fatico a capire, è come facessero, migliaia di anni fa, a essere così profondamente collegate culture fisicamente molto remote. Anche prima di Alessandro Magno, di Marco Polo o di Vasco da Gama, quando si andava a piedi, a cavallo, a dorso di cammello o su fragili imbarcazioni senza bussola, c’era più comunicazione fra culture lontane di quanto, nella percezione di oggi, può sembrare possibile.
I motivi, probabilmente, sono due. Il desiderio di conoscere – e perciò di comunicare – che (almeno per alcuni, i più curiosi e consapevoli) è sempre stato più forte degli ostacoli. E le radici comuni, anche culturali, che nella diaspora originaria della specie sono state portate in ogni angolo del mondo. Probabilmente è un insieme delle due cose – e avremo ancora molto da imparare dalle scoperte dell’antropologia e della paletnologia.
Insomma la “globalità” non è nuova. Ma oggi è più diretta, immediata, incombente. È comprensibile che ci faccia paura – ma in realtà è una risorsa molto più di quanto sia un problema. Non sapere che cosa accade in terre lontane vuol dire essere esposti a ogni sorta di pericoli e di problemi senza accorgercene fino all’inevitabile momento in cui ne subiamo le conseguenze.
Anche questo è uno sviluppo troppo “nuovo” per poter aver imparato come governarlo. Ma non c’è altra strada che un miglioramento della conoscenza. È disperatamente stupido non badare a cose che sembrano remote solo perché non sono nel nostro piccolo vicinato.
Essere meglio informati, e soprattutto capire di più, è impegnativo. Ma è indispensabile se vogliamo che le complesse e molteplici risorse di comunicazione, invece di darci un preoccupante spettacolo di confusione e sgomento, diventino strumenti per migliorare un habitat che non possiamo più immaginare circoscritto nel minuscolo orizzonte della nostra esperienza quotidiana.
È un’evoluzione “accelerata”?
Un gioco noto, e forse un po’ banale, è definire un’epoca come se fosse una giornata. Le origini della specie umana risalgono a circa un milione di anni fa. Ma possiamo limitarci a un periodo molto più breve.
Se collochiamo, pressappoco, l’inizio dell’era paleolitica a 40 mila anni fa, e da lì facciamo cominciare la giornata, troviamo la fusione dei metalli dopo le nove di sera – e poco prima la scrittura. La grande fioritura della cultura ellenistica è circa alle 22,30 – il Rinascimento un’ora dopo, cioè circa venti minuti prima della mezzanotte. La scienza “moderna”, cioè il predominio del metodo sperimentale, nell’ultimo quarto d’ora.
Il metodo di Gutenberg per la stampa compare alle 23,40. Le macchine a vapore alle 23,51. Le lampadine e i motori elettrici quattro o cinque minuti dopo. Il telegrafo nasce sei minuti prima della mezzanotte. Il telefono, il cinema, l’automobile e l’aeroplano intorno ai 4 minuti, la radio 3, l’energia atomica e la televisione 2. Il prototipo degli elaboratori elettronici si realizza due minuti prima del momento in cui siamo, l’internet uno (venti secondi da quando la rete è diventata diffusamente accessibile). La telefonia mobile esiste da due minuti, la sua ossessiva diffusione da dieci secondi.
Sull’esattezza numerica di questi calcoli non scommetterei un centesimo,
ma ciò che conta non è la precisione matematica,
è il senso generale dei tempi di evoluzione.
La sindrome della gatta frettolosa
Qualcosa, davvero, sta accelerando. Ma, proprio per questo, diventa sempre più pericoloso lasciarsi travolgere dalla fretta. Ciò che non abbiamo trovato il tempo di capire quando avevamo la possibilità di pensarci si trasforma in un pericoloso errore quando viene il momento in cui, davvero, occorre una decisione veloce.
Ernest Hemingway definiva la fretta come «quella esaltante perversione di vita, la necessità di fare qualcosa in un tempo minore di quanto ne occorre». È vero che talvolta è necessario. E, se ci si riesce, può essere entusiasmante. Ma la mania della fretta senza motivo è pericolosamente stupida.
Vedi La stupidità e la fretta, capitolo 16 di Il potere della stupidità.
Il proverbio della gatta frettolosa e l’antico apologo della lepre e della tartaruga sono validi quanto erano migliaia di anni fa. Oggi come allora, si perde molto più tempo a ritrovare la strada perduta che a organizzare il percorso prima di partire. Chi sa davvero capire e decidere in fretta, quando è il momento di farlo, non è il frettoloso. È chi è preparato a farlo bene, perché ha costruito negli anni, con pazienza e disciplina, un patrimonio di esperienza e competenza.
La fretta non è velocità, spesso è il contrario. E le scelte affrettate possono provocare conseguenze irrimediabili – o, nella migliore delle ipotesi, generare problemi ingarbugliati che sarebbe stato molto più semplice (e veloce) evitare “pensandoci prima”.
Hic sunt leones
C’era saggezza in quegli antichi cartografi che indicavano con sincerità ciò che sapevano di non sapere. Nelle mappe di oggi nessuno scrive hic sunt leones o più semplicemente “lì non sappiamo che cosa ci sia”. È vero che abbiamo sistemi di rilevazione molto più precisi, satelliti che fotografano, sonde che esplorano le profondità della terra e le remote distanze dello spazio, eccetera. Ma sono troppo diffuse le rappresentazioni che ci danno la falsa sensazione di “sapere tutto”.
Dalla mappa di una città, spesso male aggiornata per le regole del traffico e i percorsi meno disagevoli, fino alle descrizioni dell’universo che tentano di “dare per certe” conoscenze che l’astrofisica continua a mettere in discussione, dobbiamo smettere di “fingere di sapere” e ammettere con chiarezza quante e quali sono le cose che non sappiamo o che non abbiamo capito bene.
Nossignori, quella che propongo non è umiltà – e tantomeno rassegnazione. Per quanto possa essere rischiosa e scomoda, è irrinunciabile l’arroganza di Prometeo. Può essere solo disprezzata (e comunque corre gravi rischi) una misera umanità che rinunci a essere Ulisse (non lo sventurato Odisseo di Omero, che stava solo cercando di tornare a casa, ma l’Ulisse di Dante «fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza»).
Se le ricerche sulle “capacità cognitive” continuano a confermare che un’estesa ricerca delle conoscenza è una caratteristica del genere umano, diversa da ogni altra forma di vita conosciuta, non possiamo suicidare il nostro sviluppo, anzi il senso sostanziale della nostra esistenza, fingendo di sapere ciò che non sappiamo. È molto più importante, e interessante, badare all’immensa vastità (nel “grande” come nel “piccolo”) di ciò che ancora possiamo scoprire.
Per capire il nuovo, riscoprire l’antico
Oggi abbiamo strumenti che, pochissimo tempo fa rispetto alla storia umana, erano difficilmente immaginabili. Ma, per quanto ci sembrino abituali, non abbiamo ancora capito bene come usarli. Crediamo di essere “padroni” di queste evoluzioni, ma in realtà la nostra capacità di gestirle è molto confusa.
Può aiutarci un fatto evidente, di cui si tiene troppo poco conto. Gli strumenti crescono e si evolvono, ma la sostanza non cambia. Come dicevo all’inizio, fin dalle più remote origini ci sono sempre state parole e lingue, pensiero e arte, poesia e narrazione, pittura e scultura, architettura e musica, spettacolo e teatro . Ci siamo sempre espressi per segni e simboli, gesti e parole, ragione ed emozione.
Ci sono più somiglianze che differenze fra il frastornato homo cosiddetto sapiens nell’era dell’elettronica e quei remoti progenitori che l’antropologia ci sta aiutando a capire un po’ meglio.
Quella che sto cercando di dire è una cosa molto semplice, anche se spesso dimenticata. Comunicano le persone, non gli strumenti. Le tecnologie possono essere affascinanti. Se e quando funzionano bene – e sono usate con criterio – possono essere molto utili. Ma la risorsa fondamentale della comunicazione è una: la nostra umana capacità di ascoltare e di farci capire.