Numero 51 – 18 ottobre 2000 |
 |
1. Editoriale:
I “baroni ladroni”
(la storia è vecchia) |
|
|
L’origine dei robber baron
si perde nella notte dei tempi. Pare che risalga al medioevo,
quando feudatari terrieri raccoglievano dogane e gabelle.
Combattuti non solo da occasionali (e leggendari) Robin Hood
ma soprattutto da organizzazioni sistematiche e con forti
convinzioni filosofiche, come i Templari. Non mi sembra
casuale che la definizione sia ritornata di attualità a proposito
di alcune situazioni che riguardano le tecnologie di oggi e la
cosiddetta “nuova economia”. L’ha citata,
per esempio, l’attorney general Janet Reno
nel corso dell’azione legale contro la Microsoft.
Ma quella citazione non è un caso isolato.
Di “baroni ladroni” si parla abbastanza spesso negli
Stati Uniti. C’è perfino un videogioco che si chiama
1830: Railroads and Robber Barons.
In tempi moderni la definizione robber baron fu adottata
nel 1934 da un economista americano, Matthew Josephson; e poi
fu ripresa da parecchi altri autori (compresi alcuni libri
recenti sull’argomento). Il problema, che si era posto alla
fine del Settecento e poi di nuovo con lo sviluppo delle
ferrovie, e anche in questo secolo in occasione di parecchie
spericolate (e truffaldine) operazioni in borsa, è
abbastanza complesso; ma si può riassumere in una
domanda. Certi personaggi che hanno accumulato immense
fortune sono “capitani d’industria” (cioè
egoisti ma utili alla crescita generale del benessere) o sono
“baroni ladroni”, cioè grassatori che hanno
arricchito se stessi ma rovinato l’economia degli Stati Uniti
e del mondo, sfruttato spietatamente un gran numero di
persone dentro e fuori i confini del loro paese, insomma
malfattori le cui imprese si sono risolte in un grave danno per tutti?
In alcune situazioni, la risposta è facile. Per
esempio erano tipici “ladroni” Jim Fisk e Jay
Gould, che nel 1869 cercarono di impadronirsi di tutto l’oro
degli Stati Uniti. Non ci riuscirono, e così si
buttarono a speculare sulle azioni delle ferrovie; quando gli
azionisti si accorsero che erano vendute molto al di sopra
del loro valore, le compagnie ferroviarie andarono in
fallimento; ma i due furfanti erano scappati con un cospicuo
“malloppo”. E come loro tanti altri che, in tanti
periodi diversi – anche recenti – hanno imbrogliato tutti (il
mercato, gli investitori, gli azionisti) lasciando in giro
titoli che non hanno più alcun valore se non come
pezzi di carta che forse possono interessare qualche
collezionista o antiquario.
In altri casi, invece, c’è ancora dissenso fra gli
storici e gli studiosi su quanto “ladrone” o quanto
“utile imprenditore” sia stato questo o quel
multimiliardario del passato. E su quelli di oggi... i
dissensi sono ovviamente ancora più forti, anche per
la non poca influenza esercitata dagli interessi in gioco.
Con una preoccupante tendenza del sistema informativo
dominante a servire gli interessi più potenti e ad
attenuare e smussare (se non soffocare del tutto) ogni voce
di critica o di dissenso.
Lascio agli storici dell’economia il compito di giudicare
i baroni del passato; e “ai posteri l’ardua
sentenza” di valutare l’esito delle speculazioni di
oggi. (Mi sembra che alcune, abbastanza facilmente
identificabili, abbiano già fatto danni gravi e
continuino a farne; ma ciò che mi interessa in questo
articolo è cercare di capire la natura del fenomeno
più che valutare i comportamenti di questa o quella
impresa).
Il fatto è che in tutto questo non c’è
nulla di nuovo; e quindi è sbagliato descrivere quel
genere di operazioni come “nuova economia”. La
(falsa) novità diventa una scappatoia. I difensori dei
“baroni ladroni” di oggi sostengono una tesi
semplice quanto falsa. Ciò che stanno facendo serve
per “costruire il futuro” e quindi è
sbagliato ostacolarli. Nessuna verifica è possibile;
il loro comportamento non può e non deve essere
giudicato. Tutti i criteri di una sana economia (e ogni
tentativo di contrastare monopoli, cartelli, contratti
“leonini”, violazioni della privacy e dei diritti
dei cittadini, eccetera) devono essere sospesi perché
la “nuova economia” è diversa dalla
“vecchia”. Quindi se il pubblico (negli Stati
Uniti) è truffato e derubato, poco importa,
perché l’economia cresce e il “reddito
medio” aumenta. Se il resto del mondo (compresa
l’Europa) finisce assoggettato e sfruttato come le
repubbliche delle banane, è un prezzo che dobbiamo
pagare per i benefici della “globalizzazione”. E se
era giusto (nella “vecchia economia”) smembrare
organizzazioni monopolistiche (o in tanti altri modi favorire
una vera concorrenza) nella “nuova” tutto questo
non ha più alcun significato. Questa tesi è
priva di qualsiasi ragionevole fondamento; e comunque inaccettabile.
Devo confessare che sono abbastanza scettico sulle
qualità intrinseche di una disciplina come l’economia,
che non è certo una “scienza esatta” e si
è dimostrata, anche in passato, poco capace di capire
il comportamento umano e le evoluzioni sociali. E anche le
norme e le leggi che governano la “libera
concorrenza” e la trasparenza dei mercati sono
tutt’altro che perfette. Ma ciò non significa che sia
sensata l’abdicazione di ogni analisi e di ogni verifica.
Le speculazioni, le manovre, i monopoli e i privilegi non
sono la network economy (che se fosse lasciata libera di
esprimere la sua vera natura somiglierebbe molto di
più alle libere strade aperte dai Templari che agli
arcigni castellani esattori di gabelle). Sono cose molto
vecchie – e vanno trattate come tali. Anzi, semmai, con un
po’ più di severità e di capacità
reattiva; perché se le nuove tecnologie e i nuovi
sistemi rimangono sotto il controllo di pochi interessi, e
troppo concentrati, è inevitabile che si dia campo
(come stiamo constatando) alle forme più selvagge e
traditrici di speculazione e di sfruttamento; e che si rischi
di instaurare un sistema di oligarchie e privilegi tale da
far impallidire gli aspetti peggiori delle baronie medioevali
o delle angherie dei robber baron di cinquanta, cento o
duecento anni fa. Nemmeno nel 1830 (o qualche anno dopo... la
Napoli-Portici fu inaugurata nel 1839 e la Milano-Monza nel
1840) era stato consentito a qualcuno di avere il monopolio
mondiale dei binari o delle locomotive – e contemporaneamente
di impadronirsi dei sistemi di informazione.
ritorno
all'inizio
|
 |
2. L’era web è tramontata? (George Colony) |
|
|
Cinque mesi fa avevo citato un interessante articolo di George Colony (chairman and
CEO di Forrester Research) sulle debolezze delle Dot Com.
I fatti gli hanno dato ampiamente ragione (e, come sa bene
chiunque segua un po’ da vicino le vicende nostrane, ci sono
casi italiani ancora più squallidi). Resta da capire
come si possano conciliare queste osservazioni con il
contributo che Forrester Research ha dato a molte proiezioni
esagerate e acriticamente ottimistiche sul “commercio
elettronico” (o almeno così riferite dai
“grandi mezzi di informazione”). Ma lasciamo da
parte quella contraddizione (forse solo apparente) e badiamo
alla sostanza di osservazioni che mi sembrano fra le
più acute e intelligenti sul controverso tema
dell’e-business.
Il 12 ottobre George Colony ha pubblicato un nuovo
articolo, X internet – The web will fade, in cui pone un problema
interessante. Potremmo essere vicini alla fine dell’“era
web”. Mentre l’era dell’internet è appena nata.
L’articolo comincia così.
In questo momento siamo in un posto strano. Il fetore
dolciastro delle carcasse delle Dot Com aleggia nel mondo
della borsa e del venture capital. La bolla d’aria
sull’e-commerce che gonfiava Forbes, Fortune, Business Week,
gli analisti di Wall Street, la CNBC – e altre fonti
finanziate dalla pubblicità o dai guadagni sulle
transazioni – si è sgonfiata.
Allora è finita? L’internet era una moda
passeggera?
No. Ma stiamo entrando in una nuova era. Abbiamo fatto un
po’ di ginnastica preparatoria per la internet economy.
C’è stato parecchio ansimare e sbuffare, ma la partita
non è ancora cominciata.
Molti credono che l’internet e la web siano la stessa
cosa. Non lo sono. L’internet è come un filo che
collega te e me e altri 300 milioni di persone nel mondo. La
web è un software che io metto al mio capo del filo, e
tu al tuo, per poter scambiare informazioni.
Mentre l’internet (la rete di fili) si evolve
gradualmente, il software che si appoggia sul filo può
cambiare in fretta. Prima della web, c’erano altri software
che si attaccavano all’internet. Wais, gopher e usenet erano
i sistemi dominanti; e c’erano imprese che facevano commercio
elettronico usando quei tipi di software. Poi vennero Tim
Berners-Lee e Marc Andreessen (gli inventori della web) e
tutti i vecchi sistemi caddero in ombra.
Molti fra i meno esperti pensano che la web
definirà il panorama per molto tempo. Un dirigente
dell’editoria che ho incontrato recentemente ha espresso
questo pensiero: «Oh, ho capito. Siamo nel 1952 e la web
è come la televisione. La partita si giocherà
per 20 o 30 anni e ci sarà una ABC della web, e una
CBS, e una NBC, eccetera». (ABC, CBS e NBC sono le
grandi reti televisive negli Stati Uniti – n.d.t.).
Non è così. Arriverà un’altra
tecnologia ed eclisserà la web, come quella aveva
eclissato news, gopher eccetera. E il giorno del giudizio
arriverà molto presto – nei prossimi due o tre anni,
non fra 25.
Da questo punto in avanti il mio modo di pensare si
allontana da quello di George Colony. La sua tesi è
che l’attuale sistema (web) in cui si scambiano
“pagine” sarà sostituito da un altro in cui
si scambieranno “file eseguibili”. E che, in
sostanza, da un ambiente in cui la rete è percepita
come uno strumento soprattutto di lettura si ritorni a un
sistema in cui predominano lo scambio e la collaborazione.
Questa è un’ipotesi interessante, ma non so se
l’evoluzione debba necessariamente basarsi su un cambiamento
di software; né se l’uscita dall’impero web debba
avvenire per sostituzione di una tecnologia dominante con
un’altra.
Anche oggi “non tutto è web”. La posta
elettronica, per esempio, è un sistema del tutto
diverso (anche se alcuni novellini possono percepirla come un
“sottosistema” della web). Il trasferimento dei
file, anche se “apparentemente” una funzione web,
si svolge con il protocollo FTP che è più
anziano di quindici anni. Un testo può essere letto in
HTTP (soluzione adatta per il sistema web) o presentato
in altri formati più adatti alla stampa e alla lettura su carta. Eccetera...
L’importante è capire che, come giustamente
sottolinea George Colony, l’internet non è “tutta
web” e può funzionare anche in altri modi. E
usare, secondo il caso, software e tecnologie più adatte.
L’importante è uscire dall’attuale
mentalità “web centrica” e dalla falsa
percezione che essere in rete voglia dire solo (o
soprattutto) “avere un sito web” (e che usare la
rete voglia dire “andare per siti”). Riscoprire i
valori dello scambio, dell’interazione, della collaborazione,
della condivisione di esperienza, della co-gestione di
attività di ogni specie, che sono i più
importanti.
Per la stragrande maggioranza delle imprese (e anche
delle persone che sono entrate in rete quando l’apparenza web
aveva preso il sopravvento) i valori più importanti
dell’internet sono ancora da scoprire.
Il nuovo sistema, dice Colony, sarà meno server
centric (cioè basato su siti o nodi di riferimento) e
più peer-to-peer (cioè nutrito dagli scambi fra
persone). Il che è, almeno in parte, un ritorno alle
origini della rete. Osserva anche che gli sviluppi del futuro
non verranno dalle grandi software house di oggi, né
dalle grandi operazioni centralizzate, ma (come è
accaduto per l’internet e per la world wide web) dalla
ricerca pura, dal mondo accademico e dall’opensource.
Credo che, come sempre, sia più un problema di
cultura umana che di tecnologie. Credo anche che prevedere le
soluzioni del futuro sia molto difficile, se non impossibile.
Ma l’osservazione fondamentale che sta dietro il ragionamento
di George Colony mi sembra rilevante. La vera e forte natura
dell’internet si evolve gradualmente. L’attuale orientamento
verso siti e “portali” è una parentesi ormai
vecchia, che tende a imitare il modello dei mezzi
tradizionali (costruire sistemi web come se fossero reti
televisive). Il futuro della rete si basa su una riscoperta
delle sue origini e su uno sviluppo delle sue straordinarie
possibilità di rapporti umani, scambio,
interattività e collaborazione. La storia vera
dell’internet deve ancora cominciare – nell’economia come in
quella grande parte della cultura e della società che
non erano online prima della temporanea, e ormai superata,
“era web”. Il che significa che molti protagonisti
di oggi appartengono al passato, e che i leader di domani
potrebbero essere persone finora sconosciute e organizzazioni
di cui non si è ancora scoperta l’importanza – o che
devono ancora nascere. In questo territorio mutevole e
inesplorato la cosa più importante è badare
poco alle apparenze, non seguire le mode, evitare
l’imitazione e puntare su ciò che non cambierà:
la struttura di base della rete e il valore dei rapporti umani.
ritorno all'inizio
|
 |
3. Il “male oscuro” della nuova economia
(Eugenio Scalfari) |
|
|
Su Repubblica del 15 ottobre è uscito un
editoriale di Eugenio Scalfari: Il lato oscuro della new
economy. Positivo è il fatto che ci si renda conto di
una crisi del sistema. Ma scoraggiante il modo in cui viene
interpretata. Questa non è solo l’opinione di un
giornalista famoso e molto influente. È anche la
testimonianza di un imprenditore che ha investito in
attività editoriali online – e che è
palesemente deluso dei risultati.
Come il loro “analogo” americano citato da
George Colony, sembra che gli imprenditori dell’editoria
italiana abbiano fatto un ragionamento semplice quanto
sbagliato. L’internet è come la televisione. Si
concentrerà in pochi grandi sistemi (che si chiamino
“portali” o con un altro termine di moda non
è importante). Diventerà una macchina
potentissima di raccolta pubblicitaria. Se noi, editori della
carta stampata, abbiamo perso l’autobus della televisione
dobbiamo prendere questo prima che sia troppo tardi. Se noi,
dominatori del mercato televisivo, non occupiamo questo
territorio potremmo perdere un’area importante di potere e di
guadagno.
Né gli uni, né gli altri hanno capito che
cos’è l’internet. Sono confusi e smarriti.
Si chiedono perché le loro entrate nei mezzi
tradizionali sono in forte aumento (in buona parte grazie
agli investimenti di nuove aree di concorrenza, come quella
delle telecomunicazioni) mentre i ricavi delle
attività online sono molto più scarsi del
previsto e non coprono il costo degli investimenti. E sta
diventando meno facile usare la ricetta che finora sembrava
la soluzione di tutti i problemi... fare un “colpo in
borsa“ (o una vendita a un accaparratore) con cui
rastrellare molto denaro. Così intanto si guadagna...
e poi si vedrà.
Infatti le oscillazioni della borsa sono la cosa che
più preoccupa Scalfari – e tanti altri che ragionano
come lui. L’articolo comincia con una diagnosi che sembra
sensata.
Gli scossoni delle borse hanno messo fine già da
alcuni mesi alla lunga stagione rialzista. La fase del
ribasso, o quanto meno di vistose oscillazioni nel corso dei
titoli, ha penalizzato quasi tutti i valori ma ha concentrato
i suoi effetti soprattutto sui titoli della “new
economy”, quelli direttamente legati alla rete internet
e alle sue varie applicazioni.
Questo comparto era quello che nella fase del grande
rialzo aveva realizzato plusvalenze da capogiro puntando
più su una scommessa di futuro che sulla valutazione
attuale degli asset di quelle società. Non stupisce
perciò il fatto che sia proprio questo settore ad aver
registrato fin dalla scorsa primavera un andamento più
negativo e perdite di valore più alte rispetto a tutti
gli altri del mercato finanziario. E tuttavia operatori,
grandi e piccoli azionisti, risparmiatori, economisti,
banchieri, hanno capito che qualche cosa di più
profondo è accaduto, qualche cosa che va molto al di
là delle consuete inversioni del ciclo borsistico,
molto al di là di un semplice e salutare
ridimensionamento di valori e di capitalizzazioni cresciute
troppo in fretta e senza alcun rapporto con le reali
prospettive dell’economia informatica.
Gli operatori più attenti, sull’una e sull’altra
sponda dell’Atlantico, avevano da tempo avvertito il pubblico
che la “fiesta on line” non poteva durare a lungo e
che le severe leggi del mercato avrebbero duramente
falcidiato la massa delle iniziative che si erano avventurate
senza prudenza sulle libere praterie dell’internet.
«Fate attenzione a rischiare avventatamente capitali e
risorse umane alla conquista di supposti Eldoradi – avevano
detto – perché la delusione sarà dura, pochi
sopravviveranno alla selezione, i profitti verranno tra
quattro o cinque anni e premieranno soltanto chi avrà
avuto la capacità di lanciare prodotti validi e la
possibilità di investire ingenti risorse in attesa che
i frutti maturino». Ma questi avvertimenti erano rimasti inascoltati.
Sorge spontanea una malignità... perché sui
nostri giornali, e in particolare su Repubblica, di queste
osservazioni degli “operatori più attenti”
c’è scarsissima traccia, mentre imperversano le
esagerazioni sulle “facili fortune” in rete
mescolate con fantasie pseudo-tecnologiche e vari terrorismi
su qualche virus più o meno immaginario o altre
sballate demonologie? Ma lasciamo da parte questo aspetto
della vicenda e ritorniamo al tema.
Dopo questa premessa, Scalfari commette un madornale errore.
Adesso finalmente il terreno reale sul quale va piantato
l’albero della “new economy” risulta chiaro a
tutti: la sola vera aspettativa di profitto è costituita dalla
pubblicità commerciale, tutte le altre ipotesi sono cadute.
Spero di non dover ripetere ciò che ho già
scritto tante volte, e che i migliori autori internazionali
sull’argomento hanno ampiamente spiegato. Questo modo di
ragionare non è altro che il trasferimento di logiche
vecchie sull’internet, considerata come se fosse soltanto
“un altro mezzo pubblicitario”. E una delle cause
principali dell’incapacità delle imprese (inondate di
proposte e soluzioni inadatte alle loro esigenze) di capire
come possono davvero usare la rete per fare autentica
innovazione e migliorare la loro competitività
Il resto dell’articolo è in gran parte
un’elaborazione di questa falsa premessa. Il problema
è che il mondo dell’editoria (e di conseguenza
dell’informazione giornalistica e televisiva) è quasi
tutto condizionato da prospettive di questa specie.
Ma prima di concludere sento lo sgradito dovere di
rilevare un’altra balordaggine. Che (di nuovo) non è
l’errore di una persona ma un sintomo dell’ignoranza
dominante nella nostra nomenklatura culturale.
L’itinerante, l’uomo-folla, l’uomo-solitudine e l’uomo
tecnologico determinano un salto antropologico rispetto
all’umanità che ha popolato gli ultimi due secoli. Il
disoccupato strutturale e il servo-manovale determinano a
loro volta un salto economico-sociale. Quanto al solco della
disuguaglianza, siamo anche qui in presenza di un salto
qualitativo (all’indietro): la distanza tra chi detiene il
sapere e partecipa alla distribuzione del profitto e chi
vende la propria forza lavoro di manovale in condizioni di
drammatica inferiorità; negoziale ha stravolto e
più ancora stravolgerà; il mercato del
lavoro.
Anche in questo caso si tratta di un’opinione diffusa – e
profondamente sbagliata. Quella desolante condizione umana
è il prodotto dell’epoca tardo-industriale, delle
concentrazioni che tolgono senso e valore al concetto di
“mercato”, di tecnologie farraginose e altri
ostacoli che tengono nove decimi dell’umanità fuori
dalla rete, dei grandi mezzi centralizzati e omogeneizzati.
Della televisione (che Eugenio Scalfari ha sempre odiato) e
della stampa che di quel genere di cultura è diventata
serva e strumento (problema di cui Scalfari si è
accorto, come rivela un interessante dibattito
di un anno fa; ma ha onestamente ammesso di non saper
trovare la soluzione). Se gli spietati centralizzatori della
“cultura web” riuscissero ad addomesticare
l’internet e a ridurla a una brutta copia dei mezzi
tradizionali, forse fra qualche anno raccoglierebbero
abbastanza soldi con la pubblicità per tenere in piedi
le versioni online delle loro “testate”
tradizionali (che intanto stanno perdendo vitalità e
vigore, umiliate dai miasmi delle delusioni finanziarie). Ma
se così fosse avrebbero distrutto, o gravemente
menomato, lo strumento migliore di cui disponiamo per uscire
dalla prigione e far nascere davvero una nuova stagione di
rapporti umani – e un’autentica “nuova
economia”.
ritorno all'inizio
|
 |
4. L’inganno del “grande fratello”
(Umberto Eco) |
|
|
Sull’Espresso del 12 ottobre (lo stesso numero che in un
servizio “di copertina” si dedicava alla
demonizzazione dell’internet) è
uscita un Bustina di Minerva in cui, ancora una volta,
Umberto Eco dimostra di essere uno dei pochi maitre à
penser italiani capaci di fare osservazioni intelligenti e
sensate sull’evoluzione dei sistemi di comunicazione.
Le osservazioni di Umberto Eco partono da quel programma
televisivo di cui tanto si parla (e che personalmente trovo
noioso e squallido... ma quello è un altro discorso)
per arrivare a un argomento molto diverso. Con un tono
divertente e ironico, pone un problema serio. Il tema
è così importante che questa
“bustina” merita di essere citata per intero.
A fine settembre si è svolto a Venezia un convegno
internazionale sulla “privacy”: le discussioni sono
state sfiorate più volte dall’ombra del Grande
Fratello. Ma Stefano Rodotà, garante per la protezione
dei dati personali, ha avvertito all’inizio che in sé
questa trasmissione non viola la privacy di nessuno.
Non c’è dubbio che essa solletichi il gusto
voyeuristico del telespettatore, che gode nel vedere alcuni
individui posti in una situazione innaturale, i quali debbono
fingere cordialità reciproca mentre stanno, di fatto,
scannandosi a vicenda. Ma le gente è cattiva, e ha
sempre goduto nel vedere i cristiani sbranati dai leoni, i
gladiatori che entravano nell’arena sapendo che la loro
sopravvivenza dipendeva dalla morte del compagno, ha pagato
per spiare al Luna Park la deformità delle donne
cannone, al circo i nani presi a calci dall’Augusto, o sulla
pubblica piazza l’esecuzione di un condannato. Se così
stanno le cose, il Grande Fratello è più morale
perché non solo non muore nessuno, e i partecipanti
rischiano solo qualche scompenso psicologico – non più
grave di quello che li ha portati ad affrontare la
trasmissione. È che i cristiani avrebbero preferito
stare a pregare nelle catacombe, il pretoriano sarebbe stato
più felice se fosse stato Petronio Arbitro, il nano se
avesse avuto il fisico di Rambo, la donna cannone se fosse
stata Brigitte Bardot, il condannato a morte se avesse
ricevuto la grazia. Invece i concorrenti del Grande Fratello
partecipano volontariamente e sarebbero stati disposti
perfino a pagare pur di ottenere quel che per loro è
un valore primario: vale a dire la pubblica esposizione e la
notorietà.
L’aspetto diseducativo del Grande Fratello sta altrove, e
proprio nel titolo che qualcuno ha escogitato per questo
gioco. Forse molti telespettatori non sanno che quella del
Big Brother è una allegoria inventata da Orwell nel
suo “1984”: il Grande Fratello era un dittatore (il
cui nome evocava il Piccolo Padre, cioè Stalin) il
quale da solo (o con una ristretta Nomenklatura) era in grado
di spiare tutti i suoi sudditi, minuto per minuto, ovunque si
trovassero. Situazione atroce, che ricorda il Panopticom di
Bentham, dove i carcerieri possono spiare i carcerati, i
quali invece non possono sapere se e quando sono spiati.
Col Grande Fratello di Orwell pochissimi spiavano tutti.
Con quello televisivo, invece, tutti possono spiare
pochissimi. Così che ci abitueremo a pensare al Grande
Fratello come qualcosa di molto democratico e sommamente
piacevole. Nel fare questo però ci dimenticheremo che
alle nostre spalle, mentre guardiamo la trasmissione,
c’è invece il vero Grande Fratello, quello di cui si
occupano i convegni sulla privacy, fatto di vari gruppi di
potere che controllano quando entriamo in un sito
sull’internet, quando paghiamo con la carta di credito in un
hotel, quando comperiamo qualcosa per posta, quando ci viene
diagnosticata una malattia all’ospedale, e persino quando
circoliamo in un supermercato monitorati da una tv a circuito
chiuso. Si sa che, se queste pratiche non verranno
rigorosamente controllate, si potrebbe accumulare alle spalle
di ciascuno di noi una impressionante somma di dati che ci
renderebbero totalmente trasparenti, sottraendoci ogni
intimità e riservatezza.
Mentre guardiamo il Grande Fratello alla tv siamo in
fondo come quel coniuge che, leggermente imbarazzato
perché sta consumando un flirt innocente in un
baretto, non sa che l’altro coniuge sta nel frattempo
cornificandolo in modo ben più consistente. Il titolo
“Il grande fratello” ci aiuta così a non
sapere, o a scordare, che in quello stesso momento qualcuno
sta ridendo alle nostre spalle.
Ho un solo punto di disaccordo con questa analisi, ed è
un dettaglio sintattico: l’uso del futuro o del condizionale.
Come il “1984” di George Orwell non era una
previsione fantascientifica, ma una descrizione di ciò
che accadeva nel 1948, anche il “grande fratello”
che ci spia e ci controlla non è qualcosa che potrebbe
succedere domani, ma un problema che abbiamo già – e
da molti anni. Siamo tutti “schedati”, sorvegliati
e spiati – fin dalla nascita. E i poteri di ogni specie non
si accontentano; vorrebbero ancora più strumenti di
controllo, ancora più capacità di invasione
della nostra vita privata.
Una cosa che pochi sanno (forse neppure Umberto Eco)
è che ogni anno al convegno internazionale
CFP (Computers, Freedom and Privacy)
vengono assegnati gli Orwell Award: a quelle organizzazioni
(pubbliche o private) che sono più colpevoli di
incarnare il ruolo del Grande Fratello. La difesa della
libertà e della riservatezza di tutti noi è un
tema in cui siamo ancora troppo poco impegnati e su cui
occorrerebbe una mobilitazione (e una continua attenzione)
molto più cosciente e incisiva.
ritorno all'inizio
|
 |
5. Writing that works (Kenneth Roman) |
|
|
Il motivo per cui segnalo questo libro non è solo
il fatto che, nella nuova edizione appena pubblicata, sono
stati aggiunti alcuni consigli utili per la posta elettronica
e la comunicazione in rete.
Writing That Works di Kenneth
Roman e Joel Raphaelson è un “classico”
sull’arte di scrivere – per chi non ha ambizioni letterarie
ma vuole comunicare efficacemente per motivi di lavoro. Una
cosa che è sempre stata importante e lo diventa ancora
di più con l’estensione della corrispondenza che si
realizza nella rete.
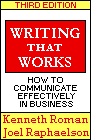
qui
si trova un’immagine più precisa della copertina
(ma più ingombrante – 45 k)
La prima edizione era uscita nel 1981 e aveva avuto un
notevole successo, che è continuato negli anni seguenti
(questo libro è stato adottato, fra l’altro, come
testo di riferimento in alcune grandi imprese internazionali).
È stato aggiornato e rinnovato nel 1992 e ora di nuovo
in questa terza edizione, pubblicata nell’agosto 2000.
Tratta tutti gli aspetti dello “scrivere efficace”
nei rapporti di lavoro. Non solo la corrispondenza ma anche
relazioni, piani, progetti, presentazioni, memorandum, appunti,
domande e risposte. Con disciplina, metodo e chiarezza.
Tradurrre questo libro in italiano sarebbe un’impresa
difficile, perché andrebbe in parte riscritto per tener
conto delle differenze lessicali. Ma proprio il fatto che
è in inglese lo rende doppiamente utile. Perché
ci sono molti suggerimenti validi in qualsiasi lingua; e
perché aiuta a esprimersi meglio e più
efficacemente nella comunicazione internazionale. Un manuale
pratico, chiaro, sintetico, pieno di osservazioni utili e
verificate dall’esperienza. Una guida concreta sui modi
migliori per farsi capire, spiegare, informare, convincere e
comunicare in modo efficace.
|
|