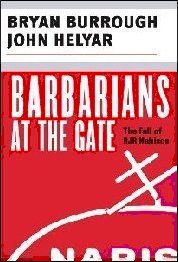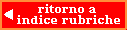L’estinzione, almeno per ora, non è totale. Alcuni esemplari, per fortuna, sopravvivono. Ma quella preziosa specie di giornalismo è diventata così rara che non è fuori luogo un elogio funebre.
Non si tratta dell’occasionale scoperta di un problema (o di una risorsa) sfuggita all’attenzione generale. Utile, nel suo genere. Ma inadeguata se non è seguita da un serio e preciso approfondimento – che, troppo spesso, manca.
Si potrebbero fare parecchi rilevanti esempi, nel vicino o lontano passato. Per cominciare, mi limito a tre, di cui due famosi (ma non so quanti, oggi, li ricordano) e uno che è sfuggito all’attenzione generale, lasciando il mondo in una distrazione di cui stiamo ancora subendo le drammatiche conseguenze.
Quello che è passato alla storia come l’affaire Dreyfus era cominciato nel 1894 con la condanna all’ergastolo di un giovane ufficiale francese, il capitano Afred Dreyfus, per tradimento. Era accusato di aver comunicato segreti militari all’ambasciata tedesca. Rimase imprigionato per quasi cinque anni in una colonia penale nella Guiana francese, chiamata “l’isola del diavolo”, prima di essere riportato in Francia per una revisione del processo.
Il 13 gennaio 1898 Émile Zola, con un furibondo articolo intitolato J’accuse, mise allo scoperto le falsità con cui l’apparato di potere militare aveva provocato la condanna dell’innocente Dreyfus mentre nascondeva le prove a carico del vero colpevole, il maggiore Ferdinand Walsin Esterhazy.
Nell’imperversante polemica, si schierarono a favore di Dreyfus altri autorevoli personaggi, fra cui Anatole France, Henri Poincaré e George Clemenceau. Ma solo nel 1906, dopo varie ulteriori tortuosità giudiziarie, Afred Dreyfus fu definitivamente assolto e reintegrato nel suo grado. Nella guerra mondiale (1914-18) divenne tenente colonnello e Officiel de la Legion d’honneur.
In tutta questa vicenda c’era un problema di razzismo. Dreyfus era ebreo. Oltre alla sua persecuzione, era una questione di civiltà. L’antisemitismo ne uscì sconfitto, ma non del tutto estirpato. Continuava ad avere inquietanti radici in Francia quarant’anni dopo, quando andò al potere in Germania.
È esemplare il caso abitualmente chiamato “watergate” (dal nome di questo palazzo a Washington dove, nel giugno 1972, avvenne un furto negli uffici del Partito Democratico). La complessa vicenda è dettagliatamente raccontata da Bob Woodward e Carl Bernstein nel libro All the President’s Men (1974).
Il titolo è palesemente ispirato da una nursery rhyme, ironica filastrocca per bambini, divenuta poi famosa nel mondo perché collocata come episodio simbolico in Alice through the Looking-Glass di Lewis Carrol (1874).
Humpty Dumpty sat on a wall,
Humpty Dumpty had a great fall.
All the king’s horses and all the king’s men
couldn’t put Humpty together again.Humpty è un personaggio-uovo seduto
in cima a un muro. Cade e si rompe.
“Tutti i cavalli e tutti gli uomini del re”
non riescono a rimetterlo insieme.Il simbolismo è evidente. Nel caso di All the President’s Men, la caduta è quella di Richard Nixon, presidente degli Stati Uniti. Bob Woodward e Carl Bernstein raccontano nel loro interessante libro (poi diventato un film, con lo stesso titolo, nel 1976) come all’inizio pensassero di avere a che fare solo con un particolare episodio di spionaggio e scorrettezza politica. Ma, un passo per volta, la loro indagine si allargava. Con crescente sgomento e preoccupazione, scoprivano sempre più ampie responsabilità, fino a trovare coinvolto il presidente Nixon – che fu costretto a dimettersi il 9 agosto 1974.
Un esempio di metodico, preciso giornalismo d’inchiesta, attentamente e pazientemente verificato in ogni dettaglio prima di arrivare a un risultato oltre ogni iniziale previsione. Profondamente diverso dalla proliferazione di congetture, pettegolezzi, ipotesi azzardate, commenti incoerenti e chiacchiere vaneggianti che ci sommergono e ci confondono in molte situazioni di oggi.
Un’indagine altrettanto precisa e accuratamente documentata è quella descritta da Ryan Burrough e John Helyar in Barbarians al the Gate (1990). Ma la lezione non è stata imparata. Ignorata dall’opinione dominante e dalle autorità di controllo.
Non c’è stata un’esplicita repressione. Burrough e Helyar non sono stati perseguitati. Il loro lavoro non è stato messo all’indice né pubblicamente bruciato. Non ci sono state accuse di diffamazione, neppure smentite o rettifiche. Più semplicemente, sulla mostruosa vicenda e sul suo significato si è stesa una torpida coltre di silenzio.
Il libro racconta, con esauriente esattezza in ogni dettaglio, la “scalata” alla RJR Nabisco nel 1988 – il primo enorme LBO (leveraged buy out) nella turbinosa storia della fantafinanza americana e mondiale. Una sarabanda di soldi immaginari, giochi in borsa, manipolazioni finanziarie, junk bonds (“titoli spazzatura”) e ogni sorta di trucchi contabili, legali e fiscali.
Barbarians al the Gate è il testo più metodico e preciso che sia mai stato scritto sui giochi demenziali della finanza. Benché meno profondamente analizzati, non sono mancati altri segnali della catastrofe mondiale che stava maturando. A differenza delle proverbiali oche del Campidoglio, sono rimasti tutti ignorati. Mentre suonavano altezzose le trombe della folle credenza che speculazioni sregolate e selvagge avrebbero miracolosamente generato “facile ricchezza per tutti”.
Sono passati venticinque anni. Il barbaro, feroce e psicopatico contagio della speculazione sfrenata ha invaso il mondo, con effetti disastrosi sull’economia reale e sulle condizioni umane e sociali.
Solo ora si cominciano a sentire voci, ancora flebili e inconcludenti, sulla necessità di arginare la pandemia. Mentre mancano quasi totalmente analisi significative da parte di un giornalismo non si sa quanto asservito, confuso o superficiale – più in generale, in tutto il sistema di cosiddetta informazione.
In Italia, nel 1974 era uscito un libro di Eugenio Scalfari e Giuseppe Turani con l’eloquente titolo Razza padrona. Una documentata analisi dei perversi incroci fra il potere politico e gli egoistici interessi di grandi imprese pubbliche e private – insieme alla corruzione e inefficienza della burocrazia.
Da allora il problema si è aggravato, e ulteriormente complicato, con storture che superano il peggio di ciò che si poteva prevedere quarant’anni fa.
(Non ho l’intenzione di essere critico verso un libro pubblicato nel 2007, che di nuovo denunciava il problema. Ma non sono d’accordo con il titolo, che è rapidamente entrato nel discutibile gergo politichese. Si tratta di una cricca, forse si può chiamare ironicamente “razza”, ma non è una “casta”. Non siamo in India e non è un’antica tradizione con profonde radici storiche e culturali).
Problemi di questo genere non sono una specialità italiana. In forme diverse, ci sono disfunzioni e prepotenze più o meno perverse in ogni parte del mondo. Ma è sconcertante che sia così scarsa la percezione dell’orrenda pandemia che affligge tutti e si incrocia con tutto: la speculazione finanziaria.
Non si tratta solo del fatto che “il sonno della ragione genera mostri”, come era scritto in un’acquaforte di Francisco Goya nel 1797.
Le tresche, palesi o nascoste, fra il giornalismo del pettegolezzo e gli intrighi del potere partoriscono una prole di mostriciattoli stupidi e insidiosi, che si accoppiano fra loro generando un marasma incomprensibile anche per i loro genitori. Questi grotteschi parassiti patogeni sarebbero ridicoli se non fossero gravemente dannosi.
C’è qualche rara sopravvivenza del giornalismo d’inchiesta. Per esempio è diffusa – e meritata – l’opinione che si possa attribuire questo ruolo alla trasmissione di Milena Gabanelli (Rai3). Ma immagino che anche lei e la sua squadra si sentano un po’ vox clamans in deserto. E non possono rimediare da soli a tutti i malanni dell’informazione. Gli approfondimenti documentati sono lunghi, faticosi e impegnativi anche per una redazione bene organizzata. (E anche questa, talvolta, si è lasciata irretire da qualche panzana).
Comunque, il problema è che le inchieste precise e approfondite, nei rari casi in cui qualcuno le fa, sono quasi sempre sommerse dall’imperversante fracasso di banalità e pettegolezzi. Anche quando suscitano, per qualche giorno, un po’ di attenzione, poi cadono facilmente nel dimenticatoio.
I giornalisti seri – o che vorrebbero esserlo – non sono una specie estinta. Ho incontrato in parecchie circostanze persone che non sono sciocche, né superficiali. Ma sono frenate, ostacolate, disorientate da direttori, redattori, editori che le costringono a lavorare troppo in fretta, senza avere il tempo di pensare. O ad occuparsi di bazzecole, quisquilie e pinzillacchere, come diceva Totò, a scapito di cose interessanti che non sono “la moda del giorno”.
Fra i mali di cui soffre l’editoria (compresa la televisione, la radio, i libri e tutte le altre forme di impresa editoriale) c’è la sindrome di Arpagone. L’ossessione scriteriata del profitto diventa autolesionismo, anche in termini economici.
Oltre ai condizionamenti che possono derivare dalla proprietà, cioè dagli interessi di chi possiede o controlla una testata, un’emittente o una casa editrice, c’è una deformante concezione del modo di guadagnare soldi.
Non tutto è scadente. Per esempio la ripubblicazione a prezzo basso dei “classici” (che non hanno costi di diritto d’autore, né di redazione se derivano da buone edizioni già esistenti) offre facili guadagni all’editore insieme a qualità per i lettori. Ma molte pratiche diffuse sono assai meno “virtuose”.
Si moltiplicano con gran fracasso “bestseller” immeritatamente famosi. Si rabberciano manuali di discutibile qualità con grossolani aggiornamenti. Su temi “al momento importanti” si scrivono articoli frettolosi e superficiali, si mandano in onda trasmissioni improvvisate, si pubblicano instant book che nessuno può aver avuto il tempo di scrivere bene.
Si pagano poco e male i giornalisti. Tenendoli il più possibile in situazioni “precarie”, mandandoli alla ricerca di scoop spesso irrilevanti, costringendoli a una fretta snervante che impedisce di lavorare con metodo e serietà.
Si moltiplicano testate affidandone la redazione a fornitori esterni che badano solo a riempire pagine di banalità e scopiazzature al minor costo possibile. Qualcuna sopravvive – e magari si organizza un po’ meglio. Molte muoiono, ma intanto forse si è guadagnato qualcosa con un po’ di pubblicità (pubblicando in abbondanza “redazionali” compiacenti per essere graditi agli inserzionisti – quelle che nel mestiere si usano chiamare “marchette”).
Si imbottiscono le emittenti televisive di trasmissioni mediocri e banali, pagando compensi assurdi per la partecipazione di personaggi noti (o di “amici degli amici”) mentre è abbondantemente dimostrato, in giro per il mondo, come si possano avere ottimi ascolti con programmi meglio concepiti, che invece di rincretinire spettatori semiaddormentati sappiano stimolare qualche curiosità su temi meno monotoni e più interessanti.
Non c’è scarsità di persone intelligenti capaci di dare un utile contributo, a un costo molto più basso del barboso salottino dei soliti “famosi”.
Invece di fare giornalismo di inchiesta, si rincorrono indagini e processi già iniziati dalla magistratura, o “scandali” proclamati da fonti non sempre attendibili, accumulando indiscrezioni confuse e devianti, ipotesi e commenti più o meno stravaganti, senza badare a come si possano offrire contributi realistici alle possibilità di soluzione o ai metodi per trovarle.
Ogni vicenda, che sia una tragedia umana, uno scandalo o un delitto, diventa il pretesto per grottesche sceneggiate in cui imperversano chiacchiere salottiere, commenti a vanvera e sproloqui divaganti. Si consultano come oracoli personaggi dello spettacolo, presunti “esperti“ e vaghi “opinionisti“ in cerca di notorietà, confondendo gli spettatori o i lettori e intralciando il percorso di indagini serie e verifiche concrete.
L’orgia dell’approssimazione e del sensazionalismo è talmente diffusa che non è raro leggere o ascoltare come “certa“ un’ipotesi smentita il giorno dopo.
Per concludere, vorrei dire che non sempre le “notizie” negative sono le più interessanti. Che lo spavento possa riempire di pubblico un teatro si sapeva anche ai tempi del Grand Guignol. E si continua oggi con il cinema dell’orrore. Ma quello è spettacolo, non presunta interpretazione della realtà.
La superficialità è talmente diffusa che può corrompere anche le “buone notizie”. Fra tanti esempi, uno di questi giorni. Si dice che è stata scoperta una cura “universale” del cancro, capace di guarire ogni genere di tumori senza usare chirurgia, chemioterapia o altre terapie aggressive.
Non è impossibile. Se vera, è una notizia straordinaria. Ma che senso ha buttarla lì senza alcun tentativo di approfondimento? Con il perverso rischio di illudere e confondere persone e famiglie in grave e dolorosa difficoltà.
E, se è vera, perché non c’è una spiegazione chiara dello stato di sviluppo, né un’indicazione di quando potrà essere disponibile nella pratica clinica?
Un po’ più di responsabilità e chiarezza, per piacere, signore e signori della stampa, della televisione e degli altri mass media (anche nell’internet c’è un’invasione di vanità, bufale, commenti strampalati e confuse elucubrazioni).
Non so che cosa si possa fare per riportare il giornalismo d’inchiesta al suo importante ruolo. Ci vorrebbe una mobilitazione dei lettori che scuotesse editori e direttori dal loro deprimente letargo. Ma mi sembra improbabile, perché l’opinione pubblica, abbacinata e travolta dalla pseudoinformazione, si trova in uno stato altrettanto confusionale.
Intanto è sempre utile imparare a leggere e ascoltare. Non si tratta di elementare “alfabetismo”, ma dell’arte sottile di capire, per non essere travolti dalla cavalcata delle bufale – e invece saper cogliere i segnali interessanti che sono quasi sempre meno rumorosi. È vano sperare che possano esistere scuole di comprendonio. L’unica risorsa è essere curiosi e ostinatamente autodidatti.