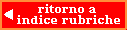Questa osservazione di Umberto Eco si trova in una “Bustina di Minerva” che ho citato recentemente a proposito di orientamenti didattici e culturali. (Vedi Il ruolo insostituibile della cultura umanistica).
«C’era una volta un signore che si chiamava Adriano Olivetti, il quale , quando ancora i computer occupavano ciascuno una stanza – e ricordo che i tecnici del primo computer Olivetti, l’Elea, avevano perso giorni o settimane per programmarlo in modo che suonasse la prima strofa del “Ponte sul fiume Kwai” (cosa che adesso può fare anche un bambino), assumeva laureati in materie umanistiche, che magari avevano fatto una tesi (ma una buona rigorosa ricerca) su Aristotele o su Esiodo, poi li mandava a fare gavetta per sei mesi in fabbrica, perché capissero per chi dovevano lavorare, e alla fine ne faceva delle menti altamente produttive per un futuro tecnologico».
Non ho avuto la fortuna di incontrare personalmente Adriano Olivetti. Ma conosco bene la sua cultura. Non solo per ciò che ho letto e imparato dall’esterno, ma anche per quattro modi di averne esperienza diretta.
La dattilografia. Ho cominciato a scrivere a macchina, quando ero un ragazzino, con una delle sue. Ed erano Olivetti anche tutte quelle che ho avuto più tardi.
(Sono particolarmente affezionato a una, che ho ancora. Non la uso più, perché ovviamente scrivo con un computer. Ma mi piace averla e guardarla. Come ho spiegato in La bella Valentina).
E poi... la frequentazione dell’ ambiente culturale di Olivetti. Ho conosciuto alcuni scrittori, filosofi, artisti che gli erano stati molto vicini. Ci siamo scambiati idee, opinioni, consensi, dissensi – spesso interessanti. E sapevamo anche scherzare. Con uno di loro, ogni tanto, giocavamo a mandarci epigrammi.
Per molti anni, il dialogo concreto con la sua organizzazione di vendita, come cliente – cioè compratore di macchine per ufficio. La migliore, nel suo genere, che sia mai esistita. Efficiente, disponibile, con una formidabile cultura di servizio. E con un appassionato orgoglio di appartenenza, che non è esagerato chiamare amore.
E infine... sei anni di lavoro al servizio dell’impresa che era stata sua. Non era più la Olivetti di Adriano. Ma si sentiva ancora la presenza della sua cultura. Purtroppo era sacrificata da diversi, e più rozzi, criteri di gestione. Intensamente vissuta con addolorato rimpianto, con delusa nostalgia. E con alcune splendide occasioni di ritornare protagonista, con nuove capacità di innovazione, sprecate per l’incoerenza di una struttura aziendale non più capace di aggregare tutte le funzioni nell’impegno per un obiettivo condiviso.
È molto triste che sia tramontata, come altre in campi diversi, una delle imprese italiane di più grande successo internazionale. E che così sia andata persa l’unica forte possibilità che avevamo per essere protagonisti nello sviluppo di tecnologie dell’informazione.
Oggi si tende a credere che l’illuminata visione politica e sociale di Adriano Olivetti fosse un’ideologia separata dalla gestione della sua impresa. È vero il contrario. Molto prima di proporla (purtroppo senza riuscirci) come programma di un movimento politico, l’aveva seriamente messa in pratica dove la gestione era sua. Con ottimi e concreti risultati.
Qual era il motivo dei successi di Olivetti? Un’intelligente convergenza di ricerca e sviluppo, cioè qualità funzionale dei prodotti, con una brillante attenzione al design – che non è solo estetica, ma anche ergonomia. Insieme a un orgoglioso e fertile “senso di appartenenza” da parte di tutti, compresa (come ho già spiegato) una formidabile organizzazione di vendita.
In un contesto dominato dagli squallidi intrighi della cattiva politica e dalla catastrofica demenza della speculazione finanziaria, l’impressione diffusa è che quella di Olivetti fosse un’utopia. Che non è vero è dimostrato dal durevole successo di imprese che ancora oggi sono gestite con quei criteri e sono in ottima salute nonostante la cosiddetta “crisi”.
Il concetto fondamentale in tutto questo si può riassumere in una parola: motivazione. Che sembra essere scomparsa dal vocabolario – e, peggio ancora, dai metodi di gestione. Della res publica come delle imprese private.
L’abolizione della povertà e della privazione, anche culturale, in ogni paese come su scala mondiale, non è solo un dovere etico. L’atroce e crescente follia della troppa ricchezza in poche mani e la troppa indigenza di tanti non è solo un’immonda ingiustizia e una causa di disperazione e violenza. È anche un sistema molto stupido che tende all’autodistruzione.
Quando si parla di “produttività”, sembra che si tratti sempre di ridurre, o pagare meno, la “manodopera”. Senza chiedersi chi, in uno squallido mondo di disoccupati o comunque poveri, potrà permettersi di comprare le scadenti carabattole così prodotte. Ci sono metodi meno perversi e molto più efficaci.
È ampiamente dimostrato che dove c’è diffusa motivazione aumentano la produttività, la qualità e la vera innovazione. Si produce ricchezza che può essere condivisa. Far partecipare chi lavora ai benefici del successo non è solo altruistica generosità. È un ottimo metodo per aumentare l’efficienza.
È un grave peccato che recenti “rievocazioni” della vita, delle opere e del pensiero di Adriano Olivetti si siano ridotte a banale e stucchevole agiografia. E sono già cadute nel frettoloso dimenticatoio. Sarebbe enormemente più utile lavorare seriamente, con pazienza e ostinazione, sul valore che la sua lezione e il suo esempio possono avere nella soluzione dei problemi di oggi.
Un piccolo post scriptum
su un argomento diversoPuò sembrare una divagazione futile, ma forse non lo è del tutto. Non resisto alla tentazione di accennare a un piccolo dettaglio, poco noto, che riguarda “The Bridge on the River Kwai”. Un bel film, del 1957, che merita di non essere dimenticato. Per chi non l’ha visto, ecco un breve riassunto.
È la storia ironica, ma anche tragicamente seria, di prigionieri di guerra catturati dai giapponesi e costretti ai “lavori forzati” per costruire un ponte su un fiume in Birmania. Fanno tutto il possibile per sabotare e ritardare la costruzione. Dopo varie e complicate vicende, riescono a minare il ponte e a farlo saltare appena è completato, insieme al primo treno militare che lo sta attraversando.
Durante il complotto, si riconoscono e si intendono fra loro fischiettando un’apparentemente innocua, buffa musichetta.
Tutti quelli che hanno visto “Il ponte sul fiume Kwai” conoscono il ritmo e il suono. Ma quasi nessuno sa le parole, che nel film non si sentono mai.
È un piccolo, beffardo ritornello sugli attributi sessuali dei gerarchi nazisti, che durante la guerra circolava fra i soldati inglesi e americani.
Hitler – has only got one ball
Göring – has two but they’r too small
Himmler – has something sim’lar
and poor old Göbb’ls has no b’lls at allNon lo traduco perché in italiano perderebbe ritmo, metrica e rime. In sostanza si basava sulla diceria (forse non infondata) che Hitler avesse un solo testicolo. Altre carenze sono ironicamente attribuite ai suoi accoliti. Può suonare grottesco, ma è meno rozzo di tante squallide orchiti mentali.
È solo una volgare, scherzosa tiritera? Non del tutto. Se ci pensiamo, possiamo accorgerci che nella storia della maliziosa canzoncina sul fiume Kwai c’è una morale di attualità al giorno d’oggi.
Fra tante astruse disquisizioni su intercettazioni e crittografia, possono funzionare bene trucchi estremamente semplici. Efficaci oggi come migliaia di anni fa. Basta che gli interlocutori conoscano un modo di esprimersi, apparentemente banale, di cui altri non hanno la “chiave di lettura”.