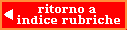Sappiamo che l’intelligenza non è solo una qualità umana. Altre specie (soprattutto, ma non solo, i mammiferi) hanno capacità di pensiero. Anche conoscenze trasmesse con metodica educazione da una generazione alla successiva. Ma (per quanto siamo riusciti a capire finora) limitate a ciò che è direttamente utile alle loro esigenze, percezioni e intenzioni.
Il desiderio di conoscenza “in assoluto” è una caratteristica della nostra specie. Filosofia e scienza, desiderio di sapere e capire anche al di là delle immediate esigenze pratiche, sono alla radice di tutto ciò che possiamo chiamare “progresso” o “civiltà”.
Fin dalle origini dell’umanità, millenni prima che nascesse la scrittura, c’era un’eloquente capacità di esprimersi per immagini. Solo in anni recenti si è cominciato a capire che le pitture trovate sulle pareti delle caverne, le sculture o incisioni in oggetti “decorati”, altri reperti che meritano di essere interpretati, non erano solo descrittive, narrative, esorcistiche o rituali.
Mentre si continuano a scoprire nuove “tracce” di queste doti espressive, migliorano anche le nostre capacità di interpretarne il significato.
Come ho scritto varie volte, recenti scoperte della paleoantropologia rivelano capacità tecniche (perciò competenze che non è improprio chiamare “scienza”) in epoche molto più antiche di quelle che si immaginavano possibili nella presunta oscurità della “preistoria”.
C’erano conoscenze scientifiche molto profonde più di duemila anni fa. Anche notevoli applicazioni tecnologiche. Ma riservate alla cerchia ristretta dei “sapienti”, non condivise con il “profano volgo” ignorante e analfabeta.
Un nuovo impulso è nato nel diciassettesimo secolo con lo sviluppo del metodo sperimentale. E nel diciannovesimo, con l’illuminismo, la volontà di diffondere estesamente il sapere. L’Enciclopedia. Cioè la divulgazione.
Dall’inizio del ventesimo secolo c’è una straordinaria accelerazione del progresso scientifico. Uno sviluppo meraviglioso e stupefacente. Con risultati sempre più evoluti e raffinati – ma un eccesso di specializzazione. C’è una preoccupante scarsità di approfondimenti “interdisciplinari”.
Diventa anche sempre più difficile, per chi non è “specialista”, capire di che cosa si tratta. Perciò diventa sempre più utile e importante il ruolo della divulgazione. Ce ne sono alcune molto ben fatte. Ma troppe no.
Accade che il compito di divulgare sia affidato a persone che conoscono l’argomento, ma non lo sanno spiegare. Ancora più spesso, e ancora peggio, a chi ha l’arroganza o la superficialità di dissertare su cose che non capisce.
Spero che questo non sia dovuto a mia ignoranza o stupidità, ma ho l’impressione che in parecchie soglie estreme dell’esplorazione scientifica neppure gli studiosi più esperti sappiano che cosa stanno scoprendo. Non è strano, probabilmente è logico e inevitabile. Ma è curioso che pochi abbiano il candore e la sincerità di ammetterlo.
C’erano barche e navi a vela, aeroplani che volavano, prima che fossero definite le teorie dell’aerodinamica. C’erano imbarcazioni e piattaforme galleggianti prima che Archimede spiegasse come si misura la spinta che riceve “un corpo immerso in un liquido”. La scoperta di Newton si dimostrò concretamente vera, ma ancora oggi non è stata trovata una definizione univoca e coerente della “gravitazione universale”.
I fatti dimostrano la correttezza della famosa formula di Einstein E=MC2. Precise definizioni spiegano matematicamente che cos’è “C” e perché è uguale al quadrato della velocità della luce. Ma sono poco illuminanti per un profano curioso, e un po’ scettico, come me. Comunque, più di cent’anni dopo la sua prima formulazione, resta ancora molto da capire nella teoria della relatività.
Nel 1869 Dimitri Mendeleiev definì con notevole precisione la “tavola periodica degli elementi”, molto prima che si scoprisse la struttura degli atomi e delle molecole in base all’interazione di elettroni e protoni.
Ma poi la cosa si è enormemente complicata con una moltiplicazione di “particelle” la cui esistenza forse può essere immaginaria – e comunque è comprensibile solo come un sistema complesso di interazioni fra loro.
In sostanza non è ancora del tutto chiaro se qualcosa di simile a una “particella” esista davvero o se ci sia un modo più semplice per capire come funziona il sistema. (E non mi risulta che qualcuno abbia mai spiegato in parole semplici come un fotone possa essere una particella e anche un’onda).
Così diceva Niels Bohr, nel 1927. «Chi non è confuso dalla teoria dei quanti non la capisce». Più icasticamente Richard Feynman, nel 1967. «Nessuno capisce la teoria dei quanti». Non sembra che oggi, dopo altri quarantasei anni di studi, le capacità di capire siano migliorate.
Anzi, ora c’è chi dice che la teoria dei quanti sia da abbandonare. Ma non è chiaro quale altro sistema teorico la possa utilmente sostituire.
Un fatto ampiamente dimostrato è che quando qualcosa diventa continuamente più complicato c’è un difetto nell’impostazione. Ma nessuno può prevedere come e quando un genio paragonabile a un nuovo Einstein troverà una spiegazione semplice. O forse un più modesto ricercatore si imbatterà “per caso” in una soluzione inaspettata. Non è da escludere neppure l’ipotesi che una risposta ci sia, nascosta chissà dove in uno studio finora trascurato, di cui anche l’autore potrebbe non aver capito l’importanza.
Le difficoltà di comprensione non riducono affatto la mia ammirazione e curiosità per i continuamente crescenti sviluppi della scienza. Al contrario, l’incontro con l’incomprensibilità dimostra l’immenso valore di un orizzonte che si estende oltre i limiti di ciò che prima ci sembrava “comprensibile”.
C’è chi afferma, non senza ragione, che oggi gli umani hanno il potere per tanti millenni attribuito agli dei. Ma, d’altra parte, è difficile adeguarci al fatto che il nostro pianeta non è il centro dell’universo, ma un minuscolo corpuscolo in una tale immensità da sbigottire anche Copernico e Galileo.
Non è sorprendente che in una situazione come questa molti studiosi preferiscano rinchiudersi nell’approfondimento di un dettaglio, che come tale può essere utile – ma così rimane sguarnito il fronte della sintesi generale.
La “disinformazione” impera, come ho già scritto molte volte (per esempio in Ingormazione, agosto 2012). Ma le balordaggini della divulgazione hanno una particolare perversità.
Un elenco sarebbe così lungo da riempire un libro – che sarebbe obsoleto prima di essere pubblicato, perché nuove idiozie proliferano ogni giorno. Perciò, come il solito, mi limito ad alcuni esempi, che spero siano sufficienti per dare una percezione del problema.
L’esplorazione di Marte è uno degli argomenti preferiti dai pasticcioni sensazionalisti. È famoso il caso dell’astronomo Giovanni Schiaparelli, che nel 1877, usando un telescopio impreciso, credette di vedere “canali” su Marte. Ma non affermò che fossero “certamente” artificiali. Un’orda internazionale di incauti divulgatori diffuse la distorta idea che Schiaparelli avesse scoperto sul pianeta forme di vita così evolute da saperli costruire.
Il sensazionalismo si è scatenato recentemente nelle pseudo notizie sul rover Curiosity. C’è chi immagina di aver visto, chissà come, una foresta su Marte – e accusa assurdamente la NASA di avere “occultato” la scoperta. (È ovvio che la NASA sarebbe felice di annunciare risultati clamorosi e così ottenere più soldi e risorse, ma giustamente procede con intelligente cautela).
Quando Curiosity stava facendo i primi, lenti passi nella sua esplorazione – e cominciando a mettere a punto i suoi sistemi di analisi – si era scatenata un’onda di insensato “ottimismo” su immaginarie scoperte di tracce biologiche sul pianeta. Fino al bizzarro estremo, in alcuni azzardati titoli, di presumere dimostrato che la vita sulla terra proviene da Marte (o da una cometa).
Recentemente, il fracasso delle scempiaggini si è diffuso in senso opposto. Si proclama il “fallimento” di Curiosity e delle sonde che osservano Marte a distanza. È vero che finora non è stata trovata alcuna prova scientificamente “certa” di tracce biologiche sul pianeta. Ma ciò non dimostra che non esistano.
In ogni caso, è molto probabile che queste esplorazioni, insieme a tante altre su luoghi vicini o remoti, ci insegnino qualcosa di importante sulle origini della vita – e su altri argomenti. Ma l’impazienza nell’azzardare ipotetiche deduzioni è il contrario di ogni consapevole metodo scientifico.
L’ostinazione dei confusionari è allucinante. Per esempio c’è chi continua a ripetere assurde panzane sulla falsità dello sbarco sulla luna nel 1969.
Una straripante occasione di bizzarri sensazionalismi riguarda il “bosone di Higgs”. Può essere mia ignoranza non aver capito che cosa sia un bosone, ma è irritante leggere o ascoltare le dissertazioni di chi ne sa meno di me.
L’ipotesi dell’esistenza di una particolare particella è stata formulata da Peter Higgs e altri nel 1964. Ci sono voluti 48 anni, e parecchi tentativi, per arrivare al momento in cui è stata verificata dal CERN. Non è possibile sapere se ce ne vorranno altrettanti per trarne qualche significativa deduzione. Forse possiamo sperare che l’attesa sia meno lunga – ma supporre che l’esito possa essere immediato è contrario a ogni ragionevole metodo scientifico.
L’attenzione dei “profani” si è accesa il 4 luglio 2012, quando si è diffusa la notizia della conferma sperimentale. E di nuovo l’8 ottobre 2013 (anche con qualche polemica) quando Peter Higgs (insieme a François Englert) ha ricevuto il premio Nobel. Il risultato è un’orgia di indigeribile aria fritta.
Una cosa mi sembra chiara. Il significato non sta nell’esistenza della particella in quanto tale, ma in ciò che ne risulta nel concetto generale di cosmogonia. Ci vorrà pazienza per arrivare al momento in cui qualcuno sarà in grado di spiegare a noi profani che cosa questo vuol dire.
Intanto circola con sciocca insistenza la grottesca definizione “particella di dio”. Rifiutata con sdegno da teologi e scienziati e comunque priva di senso.
Il problema dell’incomprensibilità esiste in molti sviluppi scientifici. Per esempio la medicina ha fatto enormi progressi, ma con un eccesso di specializzazione ha perso di vista la prospettiva di un essere umano (o, più in generale, un essere vivente) nel suo insieme. È estesa la percezione di questo problema, ma non lo sono altrettanto le soluzioni. Ed è sciaguratamente scarsa l’attenzione al fondamentale concetto di “qualità della vita”.
Un campo in cui la complicazione prevale sulla funzionalità è quello delle tecnologie. In particolare (ma non solo) nella information technology. Non è il caso di ripetere qui le molte cose che ho scritto sull’argomento. Ma si possono riassumere in due criteri elementari, quanto diffusamente ignorati.
Uno è che le tecnologie devono essere al servizio delle persone, mai viceversa. L’altro è che le soluzioni migliori sono sempre le più semplici. Le prepotenti tecnocrazie stanno ostinatamente facendo il contrario. Con conseguenze che sono già gravi e rischiano di diventare catastrofiche.
Devo ribadire qui un concetto cui sono molto affezionato. La semplicità. Complicare è facile, quanto dannoso. Semplificare è difficile, ma molto utile.
Infine... per passare a un argomento in cui ho collaudata competenza... gli strumenti di comunicazione si moltiplicano, la qualità degenera.
Le soluzioni sono soprattutto due: saper ascoltare e avere un’insaziabile curiosità. Non sono difficili e possono diventare abitudini piacevoli.
Ma si tratta, purtroppo, di capacità (e intenzioni) poco diffuse.
Supplemento
Mi sembra che l’aggiunta di alcuni ulteriori esempi e commenti sia utile. Ma non è necessaria. Ho intenzionalmente evitato di scrivere un testo troppo lungo – e spero che sia sufficiente per inquadrare il problema.Chi non sente il desiderio di andare avanti a leggere può tranquillamente fermarsi qui e (mi auguro) continuare per conto suo a distinguere fra la buona divulgazione e la diffusione di sciocchezze. Cosa importante, ma spesso non facile.
Gli scienziati (come altri “specialisti”) sono abitualmente in contrasto fra loro. Cosa giusta e necessaria, perché la scienza ha il dovere di dubitare sempre di se stessa, non considerare mai “definitiva” alcuna scoperta o teoria. Ma anche causa di molta confusione quando questa o quella scuola di pensiero si propone come “verità assoluta”, unica e dogmatica fonte del sapere.
Isaac Asimov non era solo uno dei migliori autori di science fiction (che non mi piace chiamare “fantascienza”). Era anche un serio scienziato e un bravo divulgatore. Così ha spiegato il concetto di “verità relativa”.
«Chi pensava che la terra fosse piatta aveva torto. Chi pensava che la terra fosse sferica aveva torto. Ma chi pensa che credere che la terra sia sferica sia altrettanto sbagliato quanto credere che sia piatta sbaglia più degli altri due messi insieme».
In altre parole, è giusto che a un divulgatore sia consentito semplificare – quando è il caso. Se sta spiegando che la terra non è piatta, nei limiti di quel concetto è legittimo dire che è “rotonda”, senza addentrarsi nella complessità di una forma che non è neppure precisamente un “ellissoide di rotazione”.
Così come la geometria piana è applicabile nella sua pratica semplicità a superfici poco estese (come le dimensioni di un terreno) o a tracciati ad angolo costante, come le carte nautiche basate sulla proiezione di Mercatore.
I progressi della biologia sono straordinari, anche se resta molto da imparare sulla natura e sulle origini della vita. Ma è legittimo credere e affermare che quella dell’evoluzione non è più una teoria, è un fatto dimostrato.
Però è incredibile che si continui a ripetere la sciocchezza “l’uomo discende dalla scimmia”. Cosa mai affermata da Darwin, né in alcun modo scientificamente credibile. Gli altri primati sono nostri cugini più o meno prossimi, ma non antenati.
Ho letto, anche recentemente, questa bizzarra affermazione. «Se i dinosauri non si fossero estinti i mammiferi non sarebbero sopravvissuti e l’uomo non esisterebbe». A parte il fatto che i dinosauri non sono estinti – come non scienziato, ma attento discepolo, sono convinto che i mammiferi abbiano fin dalle loro origini capacità di sviluppo superiori a quelle più muscolose, ma meno intelligenti, dei dinosauri.
Lo studio dell’evoluzione, come la storia, non si fa con i “se” o con i “forse”. Ma la paleoantropologia ci insegna che nei milioni di anni del suo sviluppo la specie umana ha rischiato davvero l’estinzione. Non per l’aggressività di predatori, né per letali epidemie infettive (estinte con lo sterminio delle loro vittime) ma per avversi cambiamenti del clima prima che l’umanità imparasse a proteggersi adeguatamente costruendo abitazioni o adattando caverne.
Ciò che si è imparato finora porta a ritenere estinte le tante specie umane (o “umanoidi”) all’infuori di una, chiamata (un po’ troppo orgogliosamente) homo sapiens sapiens. Ma molto del DNA, e dei comportamenti, di altre si scopre presente negli umani di oggi. Perciò si possono considerare tutti (o quasi) nostri antenati (compresi gli ingiustamente disprezzati Neanderthal).
Non è molto sensato giocare con le ipotesi. Ma se lasciassimo per un momento vagare la fantasia... nel caso che tutta la nostra specie si fosse estinta, chi altro avrebbe preso il sopravvento? Forse sarebbero cetacei ritornati dal mare sulla terra emersa, come è stato nelle nostre origini, visto che discendiamo dai pesci? O, se no, quali delle tante specie in cui si trovano sviluppi evolutivi tendenti in quella direzione?
Sembra comunque evolutivamente inevitabile il prevalere di una specie che più della “forza bruta” sappia sviluppare (oltre alla destrezza manuale) la consapevolezza, il pensiero, la condivisione del sapere. In una parola, la scienza. Molto resta da imparare sul significato di questa evidente realtà.
Intanto ad affermare cose insensate non sono solo i divulgatori ignoranti. Si esibiscono in acrobazie polemiche anche scienziati di professione. Un esempio fra tanti è stato pubblicato nella rivista Scientific American del luglio 2013 – Was Darwin wrong? Si afferma che Gert Korthof in un suo esperimento ha smentito Darwin. È vero il contrario.
Nell’allevamento di successive generazioni della Drosophila melanogaster (un moscerino da cent’anni preferito dagli studiosi dell’ereditarietà biologica perché è molto prolifico e si riproduce velocemente) il professor Korthof ha constatato una crescente presenza di esemplari “difettosi”, cioè privi di caratteristiche essenziali della specie.
Anche per un profano come me è ovvio che una proliferazione di mutanti “inadatti”, incapaci di sopravvivere (e di riprodursi) in un ambiente naturale, si moltiplica facilmente nell’isolamento di un un laboratorio. Questa è una chiara conferma dell’evoluzione “darwiniana”.
Intanto l’umanità sta interferendo, anche senza volerlo, con l’evoluzione naturale. Anche quando non facciamo trapianti intenzionali, voliamo, comunque viaggiamo, per tutto il pianeta. È molto difficile, praticamente impossibile, impedire che specie estranee invadano territori e acque interferendo con quelle autoctone. Cosa che talvolta può produrre risultati interessanti, ma troppo spesso mette a rischio la sopravvivenza di specie meno aggressive che erano protette dall’isolamento.
Non sono novità. Accadevano in tempi remoti dell’evoluzione umana. Con un’accelerazione da quando, dodicimila anni fa, si è cominciato a coltivare la terra e ad allevare animali. Modificando le specie per selezione pilotata, senza bisogno di manipolare il DNA. Sono, come l’opinione (in teoria) dominante, convinto dell’importanza di conservare la biodiversità. Ma occorre capire che così facendo andiamo “contro natura” perché modifichiamo l’evoluzione.
La maggior parte delle specie che scopriamo nei fossili è estinta. L’immensa, affascinante varietà di quelle ancora esistenti (di cui molte finora non scoperte) è una piccola frazione delle varianti esistite e scomparse.
Se alleviamo in cattività specie “a rischio di estinzione”, senza restituirle abbastanza presto a un ambiente “naturale” adatto, rischiamo di produrre bizzarre anomalie. Come i moscerini menomati negli esperimenti di Korthof.
Sembra che stia entrando nel regno del possibile la “riproduzione” di forme di vita antiche, come la immaginava Michael Crichton in Jurassic Park. Con la possibilità non solo di arricchire giardini zoologici e orti botanici, ma anche di fare meravigliose scoperte. Però con il rischio di scatenare problemi imprevisti.
Mi fermo qui, perché l’elaborazione di argomenti come questo potrebbe durare all’infinito. Ma due cose mi sembrano chiare.
Una è che la scienza deve essere libera di studiare tutti gli immaginabili sviluppi della conoscenza, indipendentemente dalla possibilità di immediate applicazioni pratiche.
L’altra riguarda il crescente potere che l’umanità sta conquistando, senza capirlo. Ha bisogno di essere governato da un’intelligenza più lucida, consapevole e coerente di quella che si è dimostrata finora. Questa è la più ardua delle sfide che sempre più seriamente dobbiamo imparare ad affrontare.
E ad abundantiam...
per chi ha voglia di vedere, ogni tanto, un’immagine.
Questa è una delle mappe che rappresentavano
i presunti canali su Marte.
Quante di oggi, per altri luoghi vicini o lontani,
si riveleranno altrettanto immaginarie?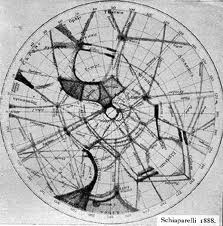
... e inoltre ...
Credevo di aver concluso “almeno per ora” i ragionamenti sull’inesauribile argomento della divulgazione scientifica. Ma non posso evitare di citare l’articolo di copertina nell’Economist del 19 ottobre 2013 – una decina di giorni dopo la prima pubblicazione di queste mie osservazioni.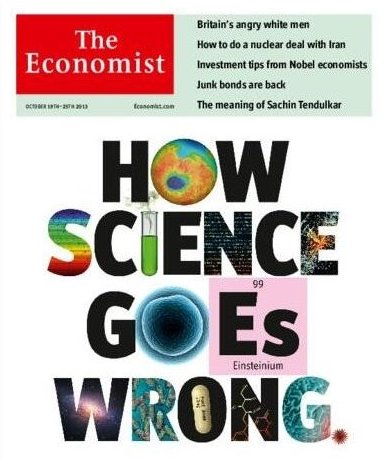
Oltre a offrici una chiara sintesi del problema, l’Economist aggiunge quattro pagine di autorevole e utile approfondimento.
È chiaro, preciso e seriamente documentato. Molto interessante non solo per gli scienziati, ma per tutti noi “profani” che abbiamo il desiderio di capire come si sta evolvendo la conoscenza e come lo sviluppo scientifico influisca sulla realtà in cui stiamo vivendo e sul futuro dove stiamo andando. L’una e l’altro in una fase di straordinaria evoluzione e di crescente complessità.
«La scienza – osserva l’Economist – ha cambiato il mondo. Ora deve cambiare se stessa».
È innegabile l’enorme valore della ricerca scientifica. Ma, proprio per questo, è pericolosa la confusione che nasce all’interno delle comunità accademiche e di ricerca, prima ancora di essere deformata dal frettoloso sensazionalismo di divulgatori incompetenti.
L’ansia di “pubblicare”, per “guadagnare punti” nella competizione carrieristica, porta troppo spesso alla proclamazione di esiti sperimentali non verificati – che si leggono in riviste specializzate. Mentre rischiano di passare inosservate scoperte autentiche, ma non capite dalle gerarchie.
Il problema, che c’è sempre stato, si aggrava con la complessità. Tocca al mondo scientifico trovare metodi per uscire dal marasma. Ma non è facile.
Esempi e opinioni
Devo ripetere, a questo punto, la premessa che avevo inserito all’inizio del primo supplemento. Non so quanti siano i lettori a cui possano interessare uteriori esempi. Ma mi sembra oppurtuno aggiungerne alcuni che aiutano in modo rilevante la comprensione del problema. E anche opinioni particolarmente interessanti.
Un caso lodevole di precisa traduzione e di “buona divulgazione” (o quasi) è l’articolo di Anna Meldolesi . Gli errori che danneggiano la credibilità della scienza pubblicato nel Corriere della Sera del 19 ottobre 2013.
In sostanza, è un ragionevole riassunto di quello dell’Economist – utile per chi non sa l’inglese o comunque preferisce leggere in italiano. È chiaro e ben fatto, ma purtroppo conclude con commento distorcente. Dice che «ci possiamo fidare» perché, per esempio, «tutti i dati ripresi dall’Economist vengono da scienziati e riviste scientifiche» e perciò possiamo contare sul fatto che «la scienza si autocontrolla». In realtà non è vero che la soluzione sia così semplice e che si possa essere così ottimisti. Ed è pericoloso crederlo.
Questo articolo si distingue dalla pletora dispersa e confusa delle troppe pseudo divulgazioni perché è scritto da una persona competente. L’autrice è una seria biologa e collaboratrice di riviste scientifiche internazionali. Ma per questo è un po’ troppo tenera verso la categoria cui appartiene.
In generale, tutte le scienze meritano il rispetto e le risorse di cui hanno bisogno, ma proprio per la loro grande importanza hanno il dovere di essere metodicamente autocritiche.
Sarebbe catastrofico se non ci fossero scienziati che scoprono e segnalano errori e mistificazioni. Co sono, ma ciò non significa che non si tratti di una pericolosa epidemia. Nel mondo accademico e nelle riviste scientifiche sono troppo spesso accreditate affermazioni di dubbia attendibilità.
Uno dei motivi, come chiaramente spiegato dall’Economist, è che le verifiche di conferma (essenziali per la credibilità di ogni ipotesi o teoria) sono spesso trascurate – e invece si dà esagerata evidenza a quelle che “fanno notizia” mentre non hanno il necessario sostegno della più umile, ma molto più utile, “ripetizione” sperimentale.
La cosa è ulteriormente aggravata dalla frettolosa confusione dei falsi divulgatori che si precipitano a diffondere qualsiasi bizzara ipotesi che sembri “rivoluzionare” le conoscenze scientifiche più credibili. Queste panzane spesso raggiungono la massima diffusione nel momento in cui una teoria azzardata ha perso credibilità perché non confermata nelle verifiche.
La conseguenza non è solo lo stato confusionale che provoca in noi profani. Produce anche un inquinamento nei metodi di ricerca e verifica.
La scienza non può progredire senza dubitare di se stessa e imparare dagli errori. Comprese le esplorazioni di ipotesi intenzionalmente sfuocate, bizzarre o incoerenti, per capire che cosa se ne può dedurre. Ma la rincorsa al “nuovo e strano”, fine a se stessa, è un esibizionismo egocentrico che serve solo a produrre confusione e sottrarre risorse agli approfondimenti più utili.
È dimostrato, per esempio, un meccanismo, che può essere involontario, di controlli condotti in modo da “autoverificarsi” anche se l’ipotesi è infondata.
Un caso caratteristico è la “saga dei “pentaquark”. Uno studio di Victoria Stodden (Columbia University), citato dall’Economist, rileva come nella fisica subatomica ci si debba districare in una enorme e sempre crescente quantità di dati – e perciò le verifiche possano essere distorte.
I quark si trovano “normalmente” in gruppi di due o tre. Intorno alla metà degli anni 2000 vari studi, che si confermavano a vicenda, rilevavano «bizzarri composti di cinque». Quando poi si fecero blind test, cioè verifiche in cui il presupposto non era condizionante dell’esito, sparì ogni traccia di “pentaquark”.
Il rischio dei “falsi positivi” (o viceversa) è diffuso in ogni genere di ricerca scientifica. A causa (non posso evitare di ripeterlo) della spasmodica caccia a ciò che è (o sembra) “nuovo” o “strano”, a scapito della molto più utile conferma e verifica di ciò che è noto e merita approfondimento.
Ma la causa più frequente di dispersione nella ricerca è l’imperversante “ansia di pubblicare ” per “fare carriera”. Si misura il valore di un ricercatore (e di una rivista specializzata) dal numero di pubblicazioni, senza badare alla loro qualità. Questi sono solo due fra molti esempi citati dall’Economist (come li ha tradotti e interpretati Anna Meldolesi in italiano).
«Il mese scorso uno studio appositamente [e palesemente] sbagliato è stato inviato a 304 riviste scientifiche per vedere quante avrebbero accettato di pubblicarlo. Hanno risposto positivamente in 157». «Nel 2005 un epidemiologo di Stanford ha sostenuto, in base a criteri statistici, che la maggior parte dei risultati pubblicati è falsa».
Non è un problema, naturalmente, che la verifica sperimentale di un’ipotesi riveli la sua falsità – o inadeguata dimostrazione. Gli esiti negativi non sono meno importanti delle conferme. Ma il problema è che troppo spesso non sono “pubblicati”, né in altro modo condivisi dalla comunità scientifica.
«Supponiamo di cercare una correlazione fra due fenomeni e di non trovarla. Poche riviste scientifiche saranno interessate a pubblicare questo “non risultato”, ma se di questo lavoro non resta traccia è possibile che altri ricercatori si perdano nello stesso vicolo cieco». Così si scivola in un vortice di confusione e si spreca una parte esagerata delle risorse disponibili.
Segnalazioni di fattori deformanti erano presenti, anche in ambienti non strettamente scientifici, anni prima che l’Economist li spiegasse a un pubblico più esteso. Un esempio interessante è What’s Wrong With the American University System, in The Atlantic il 28 luglio 2010. È un’intervista di Jennie Rothenberg Gritz ad Andrew Hacker sul suo libro (scritto insieme Claudia Dreifus). Il titolo è Higher Education? con un grosso punto interrogativo.
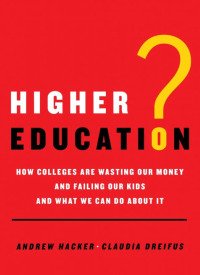
È eloquente, quanto preoccupante, questa “rimembranza” di Andrew Hacker nell’intervista. «Quando ero alla Cornell, il parlamento [americano] annunciò che stava per dare molti soldi alla ricerca sul cancro. Così un promemoria arrivò ai professori della Cornell. “Potete prendere la vostra ricerca in corso e cancrizzarla?” Diffuso, va rilevato, non solo ai docenti di materie scientifiche».
Non è difficile trovare esempi analoghi nel resto del mondo, compresa l’Italia. Ma, per ovvi motivi, pochi docenti sono disposti a dirlo pubblicamente.
Quella che segue è una sintesi delle osservazioni di un ottimo professore universitario italiano. (Fra parecchie che conosco in privato – oltre ai fatti che ho potuto constatare personalmente in situazioni in cui sono stato coinvolto).
«È bene che si capisca che c’è un “male”, nel mondo della ricerca e dell’università, che non è solo italiano. In Italia tutto è complicato perché ai mali “universali” aggiungiamo i nostri specifici, creando un mix micidiale. Ma non è che copiare pedissequamente da cosa accade all’estero sia una buona via di uscita».
«Il mondo della ricerca è malato, profondamente, gravemente. La causa della malattia è stata molto correttamente inquadrata dall’Economist – ma anche prima e da altri».
«Io una soluzione l’avrei, con molta modestia. Lasciamo andare avanti la “big science” finanziando grandi progetti eseguiti da grandi collaborazioni, in genere internazionali. Il modello cern, cioè, va benissimo. Ma, per il resto, tagliamo la borsa. Smettiamo di finanziare inutili progettucoli di ricerca fatti per “pubblicare” e manciatine di migliaia di euro per il convegnetto annuale.»
«Che l’università faccia la didattica, e su quella fondiamo le carriere, lasciando ai docenti il tempo, e un minimo di risorse, per fare la loro ricerca senza basarci la carriera. In altri termini, restituiamo alla ricerca la giusta dimensione di libertà, di qualcosa che si fa perché si ha un’autentica esigenza interiore di farla, non perché se la faccio e dimostro che sono bravo allora mi aumentano lo stipendio».
«Le riviste scientifiche servono per certificare l’appartenenza al club e decidere le carriere. Perché mi servirebbe la rivista quando c’è l’internet? Perché l’articolo sulla rivista è "certificato", la “peer review” ne garantisce la validità». Ma non è così. «Sono palesemente succhiasangue della ricerca, inutili parassiti, un avanzo di un mondo che deve scomparire. Un libero network di scienziati costerebbe molto meno e funzionerebbe molto meglio».
Il fatto è che le istituzioni scientifiche erano coinvolte nello sviluppo della rete molto prima che diventasse accessibile a noi “profani”. Quattro università collaboravano al progetto da cui nacque l’internet. Il sistema web fu definito da Tim Berners-Lee al CERN. In Italia i primi a connettersi furono istituti di fisica. Come si spiega che ancora oggi la comunità scientifica sia condizionata da ottusi apparati oligarchici – e l’informazione assoggettata a centri di potere interessati ai loro privilegi a scapito della condivisione della conoscenza?
Non credo che si tratti esattamente del perverso sistema che ha sconvolto l’economia, la società, la civiltà: la speculazione finanziaria. Ma è chiaro che c’è un’analoga, pericolosa e patologica, distorsione dei valori. Non “per caso” chi conosce l’argomento molto meglio di me parla di sanguisughe e parassiti.
In conclusione: comunque lo sviluppo della scienza rimane
grandioso, prezioso, fertile, illuminante, appassionante.
Ma guarire (o almeno ridurre) i guasti non è “moralistico”.
È una necessità concreta e urgente.