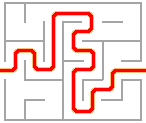
Il filo
di Arianna
luglio 2009
Giancarlo Livraghi
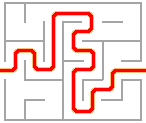
Il filo
di Arianna
Giancarlo Livraghi
Disponibile anche in
pdf
(migliore come testo stampabile)
Viva l’Italia?
(si tratta di capire quale)
“Viva l’Italia”. Strane parole, vero? Sembra che nessuno riesca a dirle sul serio. È ragionevole che un “grido” di quel genere oggi sembri retorico, antiquato, imbarazzante. Ci si può esprimere in modo più sobrio con altrettanta convinzione. Ma è proprio la convinzione che manca. Molto più spesso lo si dice in modo desolatamente ironico, amaramente deluso.
L’autocritica è una risorsa intelligente. Ma l’autolesionismo, diffuso nella nostra cultura, è un’altra cosa. Non guardiamo i nostri difetti per cercare di correggerli. Né ce ne vantiamo con arroganza, come fanno (talvolta con malagrazia) i paesi più orgogliosi. Ci accontentiamo di brontolare e lamentarci, come se fossimo condannati a una decadenza irreparabile e l’unica risorsa fosse cercare di “arrangiarci” nelle pieghe di un inesorabile declino.
Sembra che “sentirsi italiani” sia una cosa da tirare in ballo solo quando si tratta di una partita di calcio o di qualche altro evento sportivo.
Non siamo nazionalisti – e questa è una qualità. Non siamo xenofobi, se non quando un’ondata di immigrazione, stupidamente non prevista e poi male gestita, fa spuntare un razzismo da cui credevamo di essere immuni. Ma non dimentichiamo che l’Italia, fin dalle origini, è sempre stata una mescolanza di etnie e culture diverse – e questo non è un problema, è una risorsa.
Sono italiano? Non lo so. Ho avuto la fortuna di nascere in un ambiente aperto alla diversità. Fin da bambino capivo e parlavo più di una lingua, vivevo fra scaffali di libri di varia provenienza, cercavo di imparare da tutti e da tutto quello che trovavo. Non mi sono mai riconosciuto nel “prototipo di italiano” come lo propongono gli schematismi e i luoghi comuni. Mi sento sempre più estraneo a quella che “sembra essere” l’Italia e a quello che esprime la (pseudo) cultura più diffusa e più visibile.
Ma straniero non sono. Ci sono cose e persone, in tutte le regioni, per cui ho affetto, rispetto e simpatia. Anche quando (e con l’andazzo attuale succede spesso) faccio fatica a sentirmi italiano, sono comunque un sincero amico dell’Italia. E mi fa soffrire vederla malata, umiliata, intontita.
Molti paesi cercano di coltivare un’apparenza migliore della loro realtà. L’Italia fa il contrario. E lo squallore del suo apparire inquina e corrode il suo essere.Si sta cominciando a parlare del centocinquantesimo anniversario dell’unità d’Italia. Si stanno già moltiplicando i dissensi, i distinguo, le delusioni. Con l’aria che tira, sarà difficile che sia una festa. Comunque ci vuol altro che qualche effimera celebrazione per ritrovare il senso di che cosa sia l’Italia e che cosa voglia dire essere italiani.
Questa immagine non è un capolavoro, né estetico né concettuale. Ma almeno è comprensibile – e meno squallida di altre (come, per esempio, l’orrido sgorbio in cui si incarnava la stupida e fallimentare iniziativa italia.it – che qualcuno sembra voler incautamente resuscitare). Il problema è che c’è un serio difetto di prospettiva.La storia dell’Italia – e la sua identità – non è cominciata con il Risorgimento (che infatti voleva dire ri-sorgere, non nascere per la prima volta).
L’Italia non ha 150 anni. Ne ha più di 2500.
Un’esegesi storica sarebbe lunga e complessa, ma il fatto è che c’erano territori e culture chiamate Italia prima della fondazione di Roma. Già due millenni fa, ai tempi di Cesare, una larga parte della penisola era territorio metropolitano – che poco dopo si estese anche più a nord del Rubicone. Non era una colonia, i suoi abitanti erano cives. Non c’è dubbio che si chiamasse Italia, come è sempre stato in tutti i secoli seguenti.Il latino non era solo la lingua di Roma. Insieme al greco era il patrimonio comune di tutto l’impero e la lingua internazionale di riferimento – come è stata più a lungo, e più diffusamente, di qualsiasi altra, anche indipendentemente dal controllo militare o politico del territorio. In parte lo è ancora (per esempio, ma non solo, nel linguaggio della scienza).
Dilaniata da guerre e invasioni, frammentata in comuni, signorie e dominazioni straniere, comunque l’Italia era sempre, inconfondibilmente, l’Italia.
Non è mai stata solo una “espressione geografica”, anche se la particolarità della sua posizione e struttura “fisica” è, oggi come sempre, uno degli elementi della sua identità.
Proviamo a guardare un mappamondo,
un planisfero o una fotografia satellitare.
Pochi paesi, in tutto il pianeta,
sono così chiaramente e facilmente distinguibili
come questa bella penisola in mezzo al Mediterraneo.
Al tempo in cui nasceva la “letteratura in volgare” non c’era dubbio che esistesse l’Italia – e che fosse in difficoltà.
Così diceva Dante Alighieri (Purgatorio, canto VI, 76-78).
Ahi serva Italia, di dolore ostello,
nave senza nocchiere in gran tempesta,
non donna di province, ma bordello.In questo lamento c’è un’insidiosa, inquietante attualità.
E Francesco Petrarca (Canzoniere, CXXVIII).
Italia mia, benché il parlar sia indarno
a le piaghe mortali
che nel bel corpo tuo sì spesso veggo ...Con un’accorata invocazione alla madre benigna di cui ama la bellezza, la natura, l’arte, la storia e la cultura. Il diletto almo paese in cui (benché “emigrato” in Francia) si riconosce – ma che vede lacerato da guerre, violenze, faide e congiure.
Oggi non sono (o almeno non sembrano) così sanguinose le “piaghe mortali”, ma è difficile sottrarsi alla percezione che l’Italia sia malata, con un’insidiosa mescolanza di sindromi nuove e antiche.
Eppure in quella sofferente Italia stava maturando il Rinascimento. Una straordinaria, fertile mescolanza della riscoperta dell’antico con l’invenzione del moderno.
Quel ciclo si è ripetuto, in altri modi, anche in epoche successive. Ed è quella la via migliore, se non l’unica, per uscire dalla palude in cui oggi siamo impantanati.
Non siamo condannati a un’irreversibile decadenza. Non siamo quella desolante Italia che il ventenne Giacomo Leopardi descriveva, riecheggiando il Petrarca, nel 1818.
O patria mia, vedo le mura e gli archi
e le colonne e i simulacri e l’erme
torri degli avi nostri,
ma la gloria non vedo...Quando i moti carbonari erano minuscoli e clandestini,
l’unità politica non era neppure un’ipotesi,
il più scettico e “pessimista” dei nostri poeti dell’Ottocento
su una cosa non aveva dubbi: l’invocata “patria” era l’Italia
e doveva ritrovare la sua identità.Non abbiamo bisogno di malinconiche rimembranze. Non serve versare lacrime sul destino della alma terra natia o formosissima donna ridotta a una larva del suo passato, che “nuda e inerme” siede in terra negletta e sconsolata. Per quanto sia confusa, ottusa e degradante, oggi non è quella la nostra condizione.
Capire la nostra storia non vuol dire rimpiangerla. Ma senza la forza delle nostre radici saremmo molto più deboli nel guardare al futuro.
Le “glorie” sono tutte del passato, da mettere nel polveroso armadio della nostalgia? Non è vero.
Sono passati poco più di cinquant’anni da quando un paese povero, intontito da una stupida dittatura, afflitto da un esteso analfabetismo, massacrato da un’orribile guerra, ha trovato la forza di reagire, con quello che il mondo sorpreso chiamava “il miracolo italiano” (e non si trattava solo di economia).
Ancora oggi ci sono persone, organizzazioni e imprese che (lontane dalle cronache del peggio e anche, in generale, dalle luci della ribalta) stanno facendo cose, e producendo risultati, di cui (se ci badassimo) potremmo essere orgogliosi.
Il mondo pensa che in Italia ci sia molta corruzione. Purtroppo è vero. Non si tratta solo della piaga del crimine organizzato (che non è limitato ad alcune regioni, invade tutto il paese). O della rete di intrallazzi e consorterie che nessun tentativo di “pulizia” riesce a sradicare. C’è un’acquiescenza, un rassegnato “così va il mondo”, che costringe anche le persone più oneste e corrette ad accettare di essere circondate da un’equivoca atmosfera di “tolleranza”.
La corruzione è dovunque. In parecchie parti del mondo è peggio che da noi. Ciò che ci distingue non è il fatto di esserne contagiati, ma la diffusa percezione che sia un male inguaribile – o addirittura una cosa “normale”.
Il mondo pensa che gli italiani siano superficiali. Non è vero. Ma molti che “ci rappresentano” sono ostinatamente impegnati a farlo sembrare.
Siamo sommersi nel culto del futile e dell’inutile. Succede in ogni parte del pianeta. Ma da noi è diventato lo stile dominante, il prototipo culturale.
Quasi tutte le persone che conosco (e anche molte che incontro per caso) sono gentili, cortesi, amichevoli – anche consapevoli e attente. Ma quanto potranno resistere l’umanità e il buon gusto alla quotidiana esibizione della volgarità, della villania, della superficialità, della stupida arroganza?
L’Italia è un paese di straordinaria bellezza. Per paesaggi naturali e tesori artistici. Ma quando la chiamiamo “il belpaese” lo facciamo con un certo disprezzo, identificandola con un blando formaggio industriale che non è cattivo, ma è cosa da poco in confronto alla straordinaria ricchezza e varietà della nostra cucina – che non è solo il piacere di mangiar bene, ma anche la testimonianza di un patrimonio culturale.
Non è vero che siamo superati, rincitrulliti, condannati alla decadenza. Ma la nostra “cultura dominante” (non riesco a smettere di dirne male e di pensarne peggio) è travolta da un circolo vizioso di maligna stupidità, incapace di riscattarsi da un masochistico degrado.
Anche se c’è poco da giubilare, ben venga un “giubileo” nell’ormai vicino 2011 – se (cosa di cui, purtroppo, dobbiamo dubitare) potrà essere un’occasione per ragionare su chi siamo e dove stiamo andando.
Ma centocinquant’anni sono troppo pochi.
Con tutto il rispetto per il Risorgimento, che non è né la leggenda stantia degli agiografi, né quella cosuccia da poco che oggi ci pare, l’immenso serbatoio della nostra cultura ha radici molto più profonde – in due millenni e mezzo di travagliata, ma illuminante, storia.
Se il degrado continuasse, ognuno individualmente potrebbe sopravvivere, andando all’estero o “arrangiandosi” in qualche miope rifugio campanilistico. Mentre i valori della nostra cultura potrebbero essere coltivati (come è già accaduto) da altri, a modo loro, in diversi paesi.
Ma è meglio (per noi e per il mondo) che ritrovi la sua identità – cioè che sia viva l’Italia, senza punto esclamativo, ma con tutto l’impegno e il rispetto che merita. Nei fatti, non nelle invocazioni. Nella cultura e nel fare, non nella retorica.
C’è bisogno di un risveglio, di un Rinascimento (con la R maiuscola). Nonostante le deprimenti apparenze contrarie, ne siamo capaci, come lo eravamo secoli fa – in condizioni spesso più difficili e travagliate di quelle di oggi.
Se aspettiamo che qualche soluzione (chissà quale) venga “dall’alto”, possiamo piangere per altri mille anni. Mentre i più attivi o fortunati se ne vanno in Svizzera o in Australia – e chi resta si ingegna a fare il servitore di qualche califfo.
Ma mille formiche possono fare di più di un disorientato e torpido pachiderma. Cominciando con l’aprire qualche piccola breccia nell’esasperante muro di gomma dei manierismi, dei servilismi, delle abitudini e della disinformazione.
Non si potrà trovare il nutrimento nella banale ed effimera retorica dei proclami e delle celebrazioni. Ma vogliamo provare a uscire dal pantano? Certo nessuno ci regalerà un “miracolo”, ma ritrovare il lume della ragione potrebbe produrre risultati sorprendenti.
Mi sono fatto prendere da una crisi di ottimismo?
No, non sono così stupido.
Sto solo cercando di dire
(a me stesso prima che a chiunque altro)
che
lamentarsi non serve, deprimersi è triste
quanto inutile,
subire è miope, rassegnarsi è umiliante, obbedire è debole,
non basta sfogarsi nel pettegolezzo e in qualche pasquinata.
È meglio rimboccarsi le maniche e cercare di fare qualcosa.
È online una versione aggiornata di questa pagina (giugno 2011)
perché il ragionamento continua anche dopo il 150o anniversario.